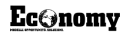Educazione, inclusione e contrasto alla povertà educativa
Edizione 2025
Position paper a cura di Giuseppe Coco e Raffaele Lagravinese
Ridurre la povertà educativa: la scommessa sul futuro
Premessa
Negli ultimi anni, istituzioni internazionali come l’OCSE1 hanno posto l’accento sull’analisi della povertà educativa. Una condizione che ostacola l’accesso a un’istruzione ed a una formazione adeguata, privando le ragazze ed i ragazzi di strumenti necessari per sviluppare pienamente le proprie capacità, realizzare le proprie aspirazioni e partecipare attivamente alla società. Come messo in evidenza dal report OCSE, uno degli aspetti più preoccupanti della povertà educativa è la sua trasmissione intergenerazionale: i bambini che crescono in famiglie con basso livello di istruzione hanno maggiori probabilità di riprodurre le stesse condizioni di svantaggio, perché non ricevono gli strumenti necessari per migliorare la propria situazione. Questo crea profonde disparità territoriali, con alcune aree del paese più colpite rispetto ad altre.
Date le complessità dei contesti in cui le istituzioni scolastiche operano, è necessario adottare un approccio multidimensionale del fenomeno, che sia in grado di collegare i risultati scolastici al contesto familiare, economico e sociale in cui i giovani crescono e si formano.
Fino ad alcuni decenni fa, infatti, il dibattito in Italia era incentrato in modo quasi del tutto unidimensionale sull’abbandono scolastico, un problema serio del nostro paese e una vera piaga nel Mezzogiorno, che pur tuttavia non rappresentava l’unica criticità da affrontare.
Questo nuovo modo di valutare le criticità scolastiche guardando a diversi aspetti, è stato di recente adottato anche dall’Istat, che dal 2023 ha istituito una Commissione scientifica inter-istituzionale con l’intento di definire e misurare la povertà educativa in modo più ampio per individuare le aree territoriali prioritarie verso cui indirizzare investimenti e interventi. Questo nuovo approccio, supportato dalla crescente disponibilità di dati dettagliati, ci permette, in questo position paper, di condurre un’analisi comparativa delle performance scolastiche degli studenti italiani, mettendole in relazione con le risorse disponibili e ponendo particolare attenzione alle differenze territoriali per discutere le politiche più adeguate.
Come performa comparativamente la scuola italiana
Un confronto della scuola italiana con quella degli altri paesi sviluppati può essere fatto sul piano degli abbandoni e con le statistiche PISA sugli apprendimenti degli studenti di 15 anni. Se guardiamo all’abbandono, il quadro è negativo ma non drammatico, come 25 anni fa (vedi sezione successiva). Anche il quadro comparativo tracciato da PISA presenta aspetti complessivamente soddisfacenti, considerando che l’Italia è in effetti tra i paesi che finanziano meno l’istruzione sia con fondi pubblici che privati.
Nella Figura 1 riportiamo un grafico che confronta i punteggi medi riportati nel 2022 nella prova di matematica in PISA con un indice della diseguaglianza degli esiti nella stessa prova per l’Italia e altri paesi selezionati (selezionati principalmente tra le eccellenze). Si vede chiaramente come, in termini di punteggio medio (asse verticale), l’Italia non performi affatto male, è sostanzialmente nella media OCSE e riporta risultati medi praticamente uguali a Francia e Germania, che spendono per l’istruzione alcuni punti di Pil in più. Sono riportati anche paesi che eccellono nei punteggi medi, come alcuni paesi nord-europei e orientali che però spesso differiscono molto in quanto a diseguaglianza dei sistemi (asse orizzontale). L’Italia ha un tasso di variabilità (diseguaglianza) piuttosto basso nella comparazione anche con Francia e Germania.
Figura 1: Performance media e variabilità dei punteggi, paesi selezionati. PISA, OCSE (2022)
Fonte: Elaborazione su dati PISA, OCSE (2022)
La scuola italiana, quindi, performa abbastanza bene per quanto riguarda gli esiti ma soprattutto è relativamente equa rispetto a paesi comparabili. La relativa equità complessiva, tuttavia, può nascondere una diseguaglianza territoriale importante. Va anche notato che la scuola italiana ha migliorato la propria performance relativa in PISA fino al 2015. Nelle ultime due rilevazioni (2018 e 2022) invece i punteggi medi peggiorano, come quelli di gran parte dei paesi2.
L’abbandono scolastico
Alla fine del secolo scorso l’abbandono era senz’altro il problema principale per la scuola italiana. Il 25% dei ragazzi tra 18 e 24 anni non aveva completato l’obbligo scolastico su scala nazionale e in alcune parti del Mezzogiorno questo tasso eccedeva il 30%. La Tabella 1 descrive in maniera esauriente la portata che si può definire storica dei miglioramenti conseguiti in poco più di 20 anni.
Tabella 1. Abbandoni scolastici, 2000-2023
Fonte: Eurostat
Come si vede in 23 anni l’abbandono diminuisce di quasi 15 punti su scala nazionale e anche nelle ripartizioni meridionali, Sud e Isole. E va sottolineato che continua a calare anche negli ultimi anni, in cui si presuppone che il recupero di quote ulteriori di abbandono diventi progressivamente più difficile al margine.
Il miglioramento è quasi equidistribuito nelle ripartizioni, nonostante le consistenti differenze iniziali. Di conseguenza le differenze tra ripartizioni diventano proporzionalmente maggiori. Nel 2023 ad esempio l’abbandono nelle Isole (17,2%) è quasi il 250% di quello del Centro (7%). Nel 2000 era poco più del 150%. Nel contesto di un enorme miglioramento generale, la diseguaglianza relativa tra ripartizioni è quindi aumentata.
Va notata anche la permanenza di una fortissima diseguaglianza di genere nell’abbandono, che dovrebbe essere affrontata con politiche specifiche. La differenza tra maschi e femmine nell’abbandono è di più di 5 punti percentuali in tutte le ripartizioni. In Campania e nelle Isole, di conseguenza, un maschio su 5 (il 20% circa) ancora abbandona la scuola prima del completamento dell’obbligo, un fatto inaccettabile.
Nel miglioramento dei tassi di abbandono in questi ultimi venti anni pesa anche la variabile demografica, nel senso che con una natalità decrescente probabilmente diminuisce anche il disagio estremo in alcune fasce dovuto alla numerosità famigliare, e con esso calano gli abbandoni. Qualunque sia la ragione, questa constatazione smentisce l’idea che il passato fosse una terra di abbondanza, disponibilità e fruizione di servizi pubblici. Più che dimezzare il tasso di abbandono non può essere considerato un risultato secondario. Va ricordato che, anche se con alcuni anni di ritardo, in effetti l’Italia è ormai quasi in linea con l’obiettivo europeo di un tasso di abbandono del 10 per cento (al 2020). Ciononostante, il problema rimane acuto, soprattutto per i ragazzi del Mezzogiorno.
La perfomance comparativa e la dispersione implicita.
Ma al di là del dato sugli abbandoni dobbiamo chiederci se il recupero effettuato degli studenti che uscivano dal sistema scolastico prima del completamento dell’obbligo abbia comportato una seria acquisizione di competenze, oppure si sia tradotto solo in una presenza formale tra i banchi senza miglioramenti degli apprendimenti (dispersione implicita). Più in generale sarà interessante capire quanta eterogeneità territoriale ci sia nei risutati degli studenti più problematici. La fonte che ci soccorre è la prova standardizzata che l’INVALSI tiene ogni anno in tutte le scuole italiane. L’INVALSI infatti testa le classi dalla seconda elementare all’esame di maturità (i gradi testati sono II e V elementare, III media, II e V secondaria superiore).
Dall’esame di questi dati emergono molti fatti interessanti, spesso non adeguatamente notati e affrontati. Il primo è che esiste una significativa differenziazione territoriale nei punteggi e nella quota di studenti in difficoltà in Italiano e Matematica: le differenze tra le macroaree sono maggiori nella seconda materia.
Il secondo aspetto di notevole interesse riguarda l’andamento delle differenze nei diversi gradi scolastici. Non solo i punteggi medi, ma anche le differenze nella quota di studenti in difficoltà emergono non immediatamente nella scuola elementare, ma molto più evidentemente in terza media. La Figura 2 mette a confronto le distribuzioni di studenti nelle macroaree secondo il livello di competenze acquisite in II primaria e III secondaria di primo grado in matematica.
Figura 2 Distribuzione degli alunni nelle fasce di risultato e competenza, 2024
Fonte: INVALSI
Appare subito evidente come nel primo grafico a sinistra la distribuzione di esiti per il Mezzogiorno sia molto simile a quella nazionale (ci sono differenze solo per le Isole). Addirittura la percentuale di studenti nella prima classe di esiti, la peggiore, nel Sud continentale è minore di quella del Nord e praticamente indistinguibile dalla media nazionale. Un quadro simile si ritrova nella prova di V elementare. Le differenze emergono invece prepotentemente negli esiti delle prove della terza media, in cui la prima classe di esiti, assolutamente insoddisfacenti, è conseguita dal 26 e dal 32 per cento degli studenti rispettivamente nel Sud e nelle Isole, e da meno del 15% degli studenti nel Nord. Si tratta di differenze che non sono, come molti sostengono, originarie e presenti già nelle scuole elementari, ma che emergono piuttosto nei tre anni di scuola media, e che poi evidentemente pesano nella decisione di abbandonare la scuola e persistono comunque negli apprendimenti della scuola superiore.
Complessivamente quindi, il quadro degli apprendimenti è meno confortante di quello degli abbandoni, ma va detto che anche in questo caso si registrano segnali di miglioramento nel tempo. Il parametro di dispersione implicita elaborato appositamente da INVALSI ad esempio misura la quota di studenti i cui apprendimenti in Italiano, Matematica e Inglese risulta incompatibile con le capacità minime che uno studente di un certo grado scolastico dovrebbe dimostrare. Gli studenti a rischio di dispersione scolastica in terza media, ad esempio, sono riportati per diversi anni nella figura di sotto.
Figura 3. Studenti a rischio di dispersione implicita, 2019-24, Macroaree
Fonte: INVALSI
Si vede chiaramente come questo parametro cali in maniera importante nel Sud e Isole negli ultimi 3 anni, rispettivamente dal 24,8 al 16,9 e dal 28,7 al 22,6%. Un calo molto più significativo di quello del Centro-Nord per quanto le diseguaglianze rimangano enormi. Va però sottolineato che in questo calo il ruolo decisivo è svolto dall’Inglese, i cui apprendimenti migliorano continuamente. Lo stesso miglioramento non si riscontra invece nella stessa misura nell’indicatore di fragilità degli apprendimenti di Italiano e Matematica.
Cause e rimedi
Se questo è il quadro, è evidente che oggi la scuola non riesce a svolgere adeguatamente il ruolo di fattore di convergenza del Mezzogiorno, considerando che gli apprendimenti divergono in maniera così significativa. Affrontare il problema significa chiedersi cosa spieghi queste divergenze. Ovviamente esistono delle differenze dovute alla differente composizione economico-sociale delle due macroaree, con il Mezzogiorno nel suo insieme nettamente più povero. Gran parte dei centri studi sul Mezzogiorno punta poi il dito sulle minori dotazioni delle scuole meridionali. Tuttavia, mentre queste non possono essere considerate irrilevanti, l’analisi dei dati lascia grossissime perplessità sul fatto che spieghino una percentuale importante delle differenze di apprendimento. Da un lato la spesa pro-capite per istruzione nel Mezzogiorno è maggiore di quella del Centro-Nord (Conti Pubblici Territoriali), in gran parte per effetto della maggiore quota di insegnanti di ruolo e in fasi avanzate di carriera, ma anche per una maggiore presenza di insegnanti. La numerosità delle classi è infatti inferiore a quella nazionale (19 studenti per classe contro 20, dati MIUR 2020). Inoltre, non tutte le dotazioni sono inferiori nel Mezzogiorno. A differire in negativo sono soprattutto le dotazioni di infrastrutture edilizie, e la presenza di mense per il tempo pieno e asili nido (0-2 anni). Per quanto riguarda le prime è discutibile che le infrastrutture edilizie debbano avere una importanza maggiore, ad esempio, delle lavagne interattive multimediali (LIM) o della disponibilità di tablet. In ogni caso un ampio e certosino studio recente che documenta minuziosamente la minore dotazione di infrastrutture edilizie del Sud, mentre trova una generica correlazione con gli esiti, non riesce a stabilire una correlazione causale (Bucci e altri, 2024)3. A conclusioni simili arriva un ampio lavoro (Bovini e Sestito, 2020) nell’ambito del grande progetto della Banca d’Italia sui divari territoriali. Quest’ultimo conclude che a contare più di tutto sono i fattori di contesto locale (tra i quali il mercato del lavoro) piuttosto che fattori oggettivi di dotazione.
Secondo alcuni, una causa importante delle divergenze di apprendimento vada individuata nell’assenza degli asili nido e del tempo pieno. Per quanto l’ampiamento di questi servizi sia auspicabile anche per altre ragioni (il premio Nobel Heckman, ad esempio, documenta effetti molto netti in contesti molto degradati dovuti soprattutto a una riduzione del crimine e effetti sulla salute da adulti), è dubbio che gli esiti degli apprendimenti dipendano significativamente da questi fattori. Alcuni studi su INVALSI (Campodifiori e altri, 2016) e Pisa (si veda Del Boca e altri su la Voce.info) escludono effetti di lungo periodo della frequenza agli asili nido, mentre trovano effetti molto significativi della scuola dell’infanzia (3-5 anni), che però è egualmente diffusa nelle Macroaree. Peraltro, come mostrato sopra, l’aspetto che rende meno convincente l’idea che siano questi servizi a fare la differenza è che nella scuola elementare fino alla quinta classe le differenze tra Mezzogiorno e Centro-Nord sono contenute. Esplodono invece nei tre anni della scuola secondaria superiore, a una distanza importante sia dall’asilo che dal tempo pieno.
Molte di queste considerazioni sono confermate dalla prima indagine della Commissione sulla povertà educativa istituita dall’ISTAT, che nel 2024 ha presentato nel Rapporto Annuale ISTAT una sezione specifica sulla differenza Nord-Sud. Questa viene esaminata prima con riferimento alle dotazioni e ai fattori di svantaggio (le risorse, comprese le differenze economiche delle famiglie) e successivamente con riferimento all’apprendimento. Le differenze nelle ‘risorse’ sono significative, ma le diseguaglianze di apprendimento sono molto più pronunciate. L’altro aspetto sorprendente è che l’indice di correlazione tra risorse e apprendimenti è piuttosto moderato (50%).
La figura 4 infatti illustra la sostanziale debolezza del rapporto tra le due dimensioni. A fronte di questa evidenza la domanda fondamentale è cosa possiamo fare per ridurre il divario negli apprendimenti. Evidentemente le politiche recenti sul miglioramento delle infrastrutture e del gap di posti in asili nido e servizi di tempo pieno vanno perseguite con convinzione. Tuttavia, non è possibile affermare che queste politiche ridurranno in maniera significativa il divario. Sicuramente una grossa parte dei divari emergono durante la scuola, ed in particolare la scuola media. Esistono consistenti indizi che gli standard applicati dagli insegnanti nelle ripartizioni siano significativamente differenti, cioè che in effetti abbiamo due scuole nello stesso paese. Allo stesso tempo i contesti locali sembrano contare molto. Le prospettive lavorative, ad esempio, costituiscono un potente incentivo all’acquisizione di competenze, ma le minori prospettive del Mezzogiorno costituiscono un freno oggettivo a questi incentivi, anche per effetto di un settore privato di dimensioni molto ridotte e concentrato in settori senza alte specializzazioni del lavoro.
Figura 4. Diagramma a dispersione dell’indice composito per la carenza di risorse (asse x) e dell’indice composito per la difficoltà negli esiti (asse y)
Fonte: Istat, Rapporto Annuale 2024
Conclusioni
Il fenomeno della povertà educativa, in particolare nella sua dimensione territoriale, è finalmente considerato in maniera adeguata nel nostro paese, e la Commissione specifica dell’ISTAT ne è prova. La priorità su questa questione è in effetti dimostrata anche dal calo importante della dispersione scolastica negli ultimi anni, omogenea su tutto il territorio nazionale, che però, proprio perché omogenea, lascia invariata (o aumenta) la diseguaglianza tra territori. A preoccupare però a questo punto sono i divari negli apprendimenti e soprattutto la percentuale di studenti in situazioni di fragilità (ovvero che non raggiungono competenze minime per il grado scolastico in cui sono inseriti).
L’evidenza dimostra che in effetti le differenze tra territori cominciano nella scuola media (prima è facile spiegare i piccoli divari con differenze socio-economiche), e quindi essa deve essere oggetto di una vera indagine qualitativa sulle cause della performance degli studenti di tutto il paese, ma in particolare del Mezzogiorno. Soprattutto, è necessario ricostruire l’unitarietà della scuola italiana sotto il profilo dei contenuti dell’insegnamento, che evidentemente divergono sistematicamente. Una maggiore vigilanza sulla reale corrispondenza dell’insegnamento ai programmi ministeriali è pertanto necessaria da parte degli Uffici Regionali e almeno i dirigenti vanno valutati sulla base delle vere performance della scuola (magari guardando alla dinamica piuttosto che i livelli, così da neutralizzare differenze sistematiche). Questo sarebbe coerente con recenti studi (ad esempio Agasisti et al, 2024) che trovano una importanza rilevante di variabili organizzative, in particolare il clima disciplinare della scuola.
Dalla scuola media potrebbe essere necessario introdurre dei programmi di recupero sistematico, in particolare nelle aree più problematiche del Meridione, curati dal Ministero a monitorati sistematicamente per l’efficacia coi risultati INVALSI. Come pure può svolgere un ruolo significativo lo sviluppo delle comunità educanti che uniscono scuole, terzo settore, comuni, asl, tribunali per i minori, chiesa, volontariato e civismo educativo: alleanze con cui – nello spirito della Costituzione – la società civile meridionale co-partecipa alle azioni per rispondere alla povertà multi-dimensionale di bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Sarà sicuramente rilevante, infatti, la capacità di integrare risorse pubbliche e private in modo da unire scuola, poliedriche azioni educative di quartiere, sport, sostegno alle famiglie curando rigore progettuale, monitoraggio e soprattutto la valutazione d’impatto. Va segnalato al riguardo quanto si sta facendo a favore delle comunità educanti meridionali grazie al Fondo di contrasto della povertà educativa e ai diversi enti che attivano iniziative a partenariato flessibile. Grazie al Fondo – che opera in base a una legge che riconosce un credito d’imposta alle fondazioni bancarie – l’impresa sociale Con i Bambini ha attivato investimenti educativi di “diritto privato” per finalità pubbliche che nel Mezzogiorno ammontano a 190 milioni di euro, coinvolgendo quasi 100.000 minori poveri con le loro famiglie e i loro insegnanti: un vasto cantiere educativo “tra scuola e fuori scuola” che opera attraverso partenariati con numerosi enti del terzo settore, creando reti esperte nella infrastrutturazione socio-educativa in aree di forte crisi. Grazie a questo tipo di iniziative – tra le quali ricordiamo lo stesso Campionato dei Valori di cui Merita si è fatta promotrice – si stanno sperimentando differenti approcci che senza dubbio sono già alla base del recupero degli abbandoni e della limitazione delle conseguenze più gravi della povertà educativa in moltissimi contesti del Mezzogiorno.
L’istruzione è l’unico servizio in cui il prodotto dipende in maniera cruciale dalla volontaria collaborazione dei fruitori (gli studenti), ma è impossibile generare questa collaborazione se non ci sono incentivi sufficienti e una fiducia nella equanimità delle regole. Ovvero se gli studenti non credono che le opportunità costruite dagli apprendimenti nella scuola sono in effetti disponibili per tutti. È questa fiducia che va ricostruita con regole davvero uniformi.
Affrontare la povertà educativa significa dunque andare oltre l’ampliamento delle infrastrutture e degli investimenti in servizi come il tempo pieno e gli asili nido, che pure sono necessari. Quello che è ancor più necessario è un intervento mirato sulla qualità dell’insegnamento, sulla formazione degli insegnanti e sulla vigilanza sugli standard educativi uniformi su tutto il territorio nazionale. La scuola media, in particolare, si conferma un nodo critico nel percorso formativo degli studenti e richiede azioni specifiche di recupero per evitare che le fragilità scolastiche si trasformino in insuccesso formativo permanente.
In ultima analisi, la lotta alla povertà educativa è soprattutto una questione di visione strategica e di politiche efficaci che sappiano ricostruire la fiducia degli studenti nelle opportunità di crescita e realizzazione offerte dal sistema scolastico.
- OECD (2018), Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264073234-en. ↩︎
- Secondo alcuni per effetto del degrado cognitivo legato all’esposizione massiccia ai cellulari, ed in parte per gli effetti della pandemia che ha per diversi mesi spostato l’apprendimento da scuola a casa con evidenti ripercussioni soprattutto nelle famiglie più fragili. ↩︎
- In ogni caso la differente dotazione di infrastrutture edilizie non è il prodotto di una programmazione distorta a sfavore del Mezzogiorno ma dell’assenza di una progettualità coerente coi programmi nazionali. ↩︎