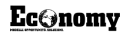Innovazione e lavoro: la formazione in azienda
Edizione 2025
Position paper a cura di Giampiero Castano
Premessa
Due capisaldi importanti della formazione professionale sono stati in Italia l’apprendistato (in origine destinato ai mestieri con alta manualità) e le scuole aziendali di alta formazione (in generale destinate alla costruzione di ruoli direzionali high & medium level).
Se fossimo in un convegno di storia economica, potremmo disquisire sulle straordinarie radici della formazione al lavoro, al mestiere ed alla gestione d’impresa che ritroviamo in molte epoche della storia nazionale antica e moderna; da Milano a Palermo siamo stati in grado di creare storie formative di alto livello culturale e di grande importanza strategica. Questo però non è il mio compito. Io affronterò il tema della formazione al lavoro come leva per la crescita nazionale e lo sviluppo del Mezzogiorno.
Il ruolo delle imprese
Un primo rilievo: tanto nell’apprendistato quanto nella formazione manageriale, il ruolo delle imprese è centrale: nell’apprendistato le competenze tecniche sono trasferite attraverso un virtuoso mix professionale – generazionale interno al processo produttivo; nelle scuole di alta formazione l’apprendimento tecnico-scientifico è accompagnata dalla trasmissione della cultura manageriale che è specifico della singola impresa.
Con l’apprendistato (reso obbligatorio in Italia con legge del 1955, poi profondamente rinnovato con il Jobs Act, legge 183 del 2014) e con le scuole professionali è stato costruito nel Secondo Dopoguerra il patrimonio di competenze tecnico professionali che ha accompagnato la ricostruzione e lo sviluppo manifatturiero. Con le scuole aziendali di alta formazione, è stata formata la classe manageriale fondamentale per gestire la crescita interna ed internazionale delle imprese italiane. Fino agli anni ’80 del secolo scorso questi due momenti sono stati fattori di successo: la rinascita industriale italiana è stata accompagnata da una accentuata capacità di dominare (pur nei limiti della nostra dimensione nazionale) una forte espansione internazionale.
Gli imprenditori nel loro insieme (e non solo i maggiori o i più avveduti) erano consapevoli della necessità di dover esercitare un ruolo attivo nella formazione professionale ad ogni livello. L’investimento in questo fattore era ritenuto strategico anche nel vasto mondo della media impresa, che considerava l’apprendistato una opportunità centrale per consolidare le imprese e proiettarle verso un futuro di crescita.
Il Mezzogiorno senza formazione per la crescita.
Va subito detto che sia l’apprendistato che le scuole aziendali di alta formazione hanno avuto uno scarso radicamento nel Mezzogiorno: le scuole Olivetti e Fiat o quelle di IRI, ENI, Finmeccanica, STET-Telecom erano (e purtroppo solo poche lo sono ancora) allocate nel Nord e nel Centro del Paese; questo non è vero per l’apprendistato, ma il suo utilizzo al Sud è stato quasi sempre avulso da programmi-progetti di strategia industriale e in troppi casi è stato strumento di contenimento del costo del lavoro o di accrescimento della flessibilità.
Eppure la formazione professionale, l’aggiornamento delle competenze così come una diffusa presenza di alta formazione imprenditoriale e manageriale, costituiscono elemento infrastrutturale fondamentale per qualsivoglia progetto di fuoriuscita da una dimensione economica ed industriale subalterna. Questa lacuna è stata presente anche nella fase di maggiore successo dei programmi importanti che sono stati messi in atto con la Cassa per il Mezzogiorno. Pochi manager sono stati espressi dalle Regioni meridionali e molto scarsa è stata la produzione di quel middle management fondamentale per dare impulso e continuità alla industrializzazione. Anche i grandi investimenti avviati negli anni ’60 e ’70 – si pensi a quelli negli impianti siderurgici, nell’automotive così come alla importante concentrazione di attività elettromeccaniche ed elettroniche in Campania soprattutto, ma anche in Sicilia con la chimica e la microelettronica – non hanno generato quel fallout che in altre realtà è stato possibile. Richiamare i nomi di manager importanti nati al Sud e arrivati alla guida di importanti imprese nazionali ed internazionali (uno per tutti, Pasquale Pistorio che dalla sua Sicilia è giunto ai vertici prima di Motorola e poi di ST-Microelectronics) non solo non è consolatorio, ma ci riporta immediatamente alla fallimentare concezione di progetti nati monchi per la assenza quasi totale di una lungimirante visione che solo la formazione professionale, manageriale ed alla imprenditorialità avrebbe potuto assicurare. Quando i grandi progetti hanno esaurito la loro spinta originaria (si pensi alla contestuale presenza dagli anni ’70 ai ’90 del secolo scorso nell’area di Caserta e Napoli di grandi imprese pubbliche e private da Italtel ad Olivetti a Siemens ad Alcatel, Face Standard, Marconi, ecc.) le professionalità operaie e tecniche generate dalla straordinaria contingenza storica sono diventate forza lavoro per il Nord o per il grande bacino del sostegno al reddito con la cassa integrazione.
Si può sostenere che l’aspetto sociale (creare posti di lavoro per fronteggiare la pesante disoccupazione) abbia prevalso sulla pur necessaria programmazione strategica degli interventi? Sì certamente, ma solo se poi si riconosce che la risposta è solo parziale e forse nemmeno così tanto importante. In realtà pochi sia nelle imprese che nelle istituzioni hanno ritenuto fondamentale insediare nel Mezzogiorno solidi centri di formazione. Le grandi imprese hanno preferito mandare i giovani laureati nelle loro scuole di alta formazione allocate in Italia o all’estero; nessuna delle grandi imprese del casertano (per riprendere l’esempio citato) ha ritenuto di insediare in quel territorio un centro formativo al quale convogliare anche i giovani laureati del Nord; neppure la “illuminata” Olivetti, che pure nel Mezzogiorno si è distinta per importanti opere di architettura industriale (già ascrivibili all’albo della archeologia industriale e la citazione non è certamente casuale).
Mezzogiorno, cambio di paradigma strategico e ruolo delle imprese per la formazione
La riflessione, pur sommaria, sul passato, può aiutarci a comprendere l’oggi con le sue prospettive.
La elaborazione di “Merita” dal 2019 ad oggi ha posto l’accento sulle caratteristiche della transizione in atto e le conseguenze per il Mezzogiorno. Abbiamo detto che le Regioni meridionali possono svolgere un ruolo strategico nella definizione di un futuro non solo determinato dal ruolo centrale nella area del mediterraneo (Convegno dello scorso anno), ma anche e soprattutto per la concentrazione nel suo territorio di opportunità industriali strategiche: energia, trasporti e industria della nutrizione. Lo abbiamo sostenuto ampiamente, soprattutto per i primi due macrosettori, in numerosi seminari svolti insieme alle imprese che più ci sono vicine. Per l’energia basta richiamare il peso delle rinnovabili nel Mezzogiorno ed il ruolo che può svolgere anche nella prevedibile ripresa di attenzione al combustibile nucleare, mentre per il trasporto sostenibile si ricorda che proprio a Sud sono in corso di realizzazione importanti impianti sia per la alimentazione elettrica, sia per la alimentazione con biocarburanti non derivati dal petrolio. E ancora, si ricorda che il Sud è protagonista nella produzione di mezzi per il trasporto su strada, aereo, marittimo e su ferrovia. Anche nel vasto settore della nutrizione molte eccellenze caratterizzate da ricerca e innovazione hanno il loro insediamento in Campania, Puglia e Sicilia.
Tutto questo richiama ad una grande responsabilità di istituzioni ed imprese per realizzare, insieme o con iniziative disgiunte ma fortemente coordinate, le strutture formative che sostengano la transizione strategica e le sue caratteristiche nel Mezzogiorno. Su questo obiettivo proponiamo tre linee di azione:
- Scuole di alta formazione manageriale progettate e realizzate da grandi imprese che si distinguono per una propria cultura manageriale. Imprese come ENI, SNAM, Terna, Ferrovie dello Stato, Italgas, Leonardo, Stellantis, Fincantieri o in prospettiva la nuova proprietà di ILVA, anche attraverso intese con multinazionali loro affini o istituti universitari già presenti sul territorio, debbono essere stimolate attraverso facilitazioni burocratiche e fiscali a realizzare Scuole interamente autogestite e destinate non solo al proprio fabbisogno, ma al più alto impegno di fertilizzare il territorio meridionale con un output in grado di arricchire le competenze manageriali dedicate a supportare con adeguata competenza una supply chain che sia sempre più capace di confrontarsi con i mercati internazionali. In questo modo si rende meno precaria la catena delle PMI funzionale al ciclo di lavoro della grande impresa, evitando gli errori commessi con le produzioni monocliente che tanti problemi stanno creando in alcuni settori interessati dalla transizione tecnologica (si pensi alla crisi dell’automotive).
- Forte rilancio delle scuole professionali ad indirizzo industriale per formare specialisti nei settori strategici per la transizione (tema di cui abbiamo trattato nella sessione precedente ma che deve essere tenuto ben presente con riferimento al ruolo delle imprese). Lascio ai lettori l’elenco di queste professionalità che però sono tutt’altro che ovvie. L’attrazione di giovani alla formazione ed al lavoro tecnico (mix di manualità e competenze tecnico-scientifiche) deve essere sostenuta da motivazioni di ordine strategico ma anche di ordine economico. Altrettanto va detto a favore degli imprenditori ai quali chiedere, a fronte di benefici fiscali e contributivi proporzionati, un impegno diretto nella costruzione degli indirizzi e nella messa a disposizione delle competenze nella attività didattica curricolare, recuperando anche in questo ordine di scuole ciò che con grande acume è stato attuato negli ITS. Le regioni avranno una funzione organizzativa, oltre al coordinamento degli indirizzi tecnico professionali. E’ del tutto evidente che dovranno avere una corsia preferenziali quelle attività formative funzionali alle politiche di consolidamento nel Mezzogiorno dei grandi settori impegnati nella transizione strategica.
- Un impegno neocorporativo per il Mezzogiorno (è una provocazione voluta) per una seria formazione continua “on the job” che sappia andare oltre la pur lodevole intuizione del “Fondo nuove competenze”. Quello che può fare la differenza è un serio progetto cogestito nelle imprese maggiori per l’aggiornamento professionale continuo che, al tempo stesso, utilizzi tutti gli strumenti di legge disponibili (politiche attive e passive) e sappia andare oltre individuando le migliori modalità per raggiungere l’obiettivo.
Credo sia possibile al Sud una simile politica del lavoro e delle relazioni industriali: non si tratta di proposte visionarie o velleitarie, ma di indicazioni utili e coerenti con la fase che il Mezzogiorno sta vivendo. Senza un protagonismo di coloro che necessariamente devono essere gli attori principali della trasformazione, questa sarà destinata ad aumentare la dipendenza, la subalternità e soprattutto l’incapacità di cogliere una occasione storica davvero eccezionale per rendere il Sud protagonista dello sviluppo di tutto il Paese.
Abbiamo voluto indicare tre ambiti di lavoro per le Istituzioni e le parti sociali; ad essi se ne possono aggiungere altri così da arricchire il progetto formativo che nelle scuole e nelle aziende deve accompagnare la transizione strategica che può realisticamente vedere protagonista il Mezzogiorno. Non si tratta di proposte visionarie o contingenti, ma del corredo necessario a un Sud che voglia raggiungere risultati positivi, strutturali e duraturi.