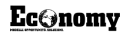Introduzione
Edizione 2025
Premessa
Da tempo sappiamo che quello che in teoria economica chiamiamo “capitale umano” costituisce sempre più il fattore decisivo per le capacità di crescita delle economie avanzate: rispetto al più antico – e più nobile – termine di lavoro, “capitale umano” è una espressione che, per un verso, risulta riduttiva per la evidente analogia con il “capitale fisico” (insieme di mezzi di produzione) ma che, per altro verso, ha il pregio di evidenziare l’importanza della qualità del lavoro e quindi dello studio, della formazione, dell’esperienza lavorativa, che quella qualità producono. E’ su questo fattore – sulla sua capacità di produrre innovazione scientifica, condivisione delle competenze, evoluzione tecnica continua e diffusa nella quotidianità dei processi produttivi concreti, sapere tecnologico da incorporare nello stesso capitale fisico – che si fonda la forza di una economia moderna ed è su questo terreno che al fondo si svolge il confronto e la competizione tra sistemi economici: la forza dell’economia statunitense, come l’avanzare dei paesi emergenti a cominciare da Cina e India.
E’ un terreno su cui l’Europa – depositaria di una cultura millenaria e di uno straordinario sapere scientifico e umanistico – ha tutte le carte in regola per svolgere un ruolo leader nel contesto globale. Per questo, senza naturalmente trascurare l’importanza dell’accesso alle materie prime critiche di cui oggi molto si parla, è principalmente il capitale umano l’elemento costitutivo essenziale della stessa autonomia strategica europea, che non può significare l’illusione dell’isolamento ma deve significare interazione attiva e non subalterna con le altre aree del mondo. Nella consapevolezza che la cura e lo sviluppo del capitale umano è la via per gettare le basi di una crescita inclusiva sia all’interno di ogni Paese sia nelle relazioni internazionali: si cresce tutti insieme e non gli uni contro gli altri, e curare ognuno il proprio capitale umano e promuovere quella cura a livello globale significa avvicinare uno sviluppo economico di cui l’uomo sia il centro di riferimento.
Competenze per lo sviluppo
La rilevanza decisiva del capitale umano è ben chiara se si guarda alle trasformazioni in corso in diversi settori dell’economia. Nell’industria, le imprese più avanzate e capaci di proiettarsi nella competizione internazionale sono quelle che fanno tesoro dei processi di innovazione scientifica e tecnologica, oggi molto connessi alla rivoluzione digitale, incorporati nelle componenti del capitale fisico utilizzato – e quindi prodotte da capitale umano a monte – o che producono mezzi di produzione avanzati – in cui sono incorporati i frutti del capitale umano direttamente utilizzato – o che organizzano – anche attraverso quei mezzi di produzione – l’attività produttiva in forme in cui i lavoratori – colletti bianchi e blu – sono soggetti attivi del governo dei processi produttivi e della loro trasformazione tecnologica. E naturalmente le tre dimensioni menzionate spesso convivono nella medesima impresa.
Nel mondo dei servizi, i settori di tipo industriale (come le cosiddette public utilities – energia, telecomunicazioni, servizi idrici e ambientali, trasporti) e quelli professionali che sono fornitori diretti di industria e servizi a carattere industriale si trovano in condizioni analoghe, nel senso che hanno bisogno di lavoratori con competenze avanzate, per esempio di tipo digitale, o comunque di competenze forti nelle rispettive mansioni produttive, come operai e tecnici qualificati. La stessa agricoltura vive oggi un processo di trasformazione molto pervasivo, in cui sia le metodologie di lavorazione sul terreno sia i processi di trasformazione agro-industriale sono investiti da avanzamenti tecnologici – digitale e non solo – che ne cambiano il volto. Per non parlare del mondo dei servizi alla persona (sanità, insegnamento, servizi professionali, cura dell’infanzia, assistenza agli anziani, attività culturali, servizi per la fruizione del tempo libero), dove la qualificazione degli addetti nelle diverse forme – scientifica, professionale, culturale, relazionale – che a quei servizi corrispondono costituisce l’elemento decisivo per il risultato “produttivo”, ossia per coloro che di quei servizi usufruiscono.
Naturalmente, quanto detto fin qui non deve farci dimenticare la presenza ancora ampia di lavori a bassa qualificazione, ripetitivi, faticosi e senza prospettive di carriera: è questo il tema della polarizzazione oggi in atto tra lavoratori che sono nelle condizioni di esercitare un controllo sulla propria attività e lavoratori che possono solo subirne le forme organizzative date. Creare le condizioni per superare questa polarizzazione significa promuovere l’evoluzione del sistema economico verso i settori e le attività a più alta qualità del lavoro – evoluzione decisiva per il futuro dell’economia italiana ed europea – e al tempo stesso curare la formazione dei cittadini affinché entrino sul mercato del lavoro con le competenze che consentono loro di essere protagonisti della trasformazione di sistema ormai necessaria.
Il Mezzogiorno tra eccellenze e ritardi
Quanto detto fin qui implica che, nella macroarea meridionale, formazione, coinvolgimento e utilizzo del capitale umano sono decisivi per sostenere il percorso di riduzione del divario con il Centro-Nord e con i Paesi europei più avanzati. Non mancano nel Mezzogiorno punti di forza su cui fare leva: dalle tante scuole, in particolare del ciclo primario, in cui gli insegnanti profondono impegno e competenze nella formazione dei bambini e dei ragazzi, ai (purtroppo) pochi ITS operanti nelle regioni del Sud, ad alcune università di eccellenza nonché alle academy ad esse collegate. Ma è bene essere consapevoli che anche sul terreno della formazione siamo di fronte a un divario che, insieme con le minori opportunità di occupazione post-formazione, è alla radice di quell’esodo di tanti giovani verso il Centro-Nord che negli ultimi venti anni ha impoverito il capitale umano del Mezzogiorno, ricchezza insostituibile per le sue prospettive di sviluppo.
Lo vediamo nel permanere al Sud di una maggiore incidenza rispetto al Centro-Nord della dispersione scolastica esplicita (bambini e ragazzi che abbandonano la scuola senza aver completato l’obbligo scolastico). E’ un fenomeno in riduzione generalizzata da anni in tutto il nostro Paese, un risultato importante, ma ciò non toglie che nel Mezzogiorno rimanga più elevato. Lo vediamo poi nella maggior dispersione implicita al Sud, segnalata dal fenomeno del peggioramento dei risultati ai test Invalsi che si riscontra nel passaggio a gradi di istruzione superiori, laddove nella scuola primaria i risultati sono sostanzialmente allineati tra le macroaree del nostro Paese. Lo vediamo nella scarsa diffusione al Sud dell’istruzione professionale e di quella tecnica, che al Centro-Nord consente a tanti ragazzi di trovare la propria strada e di inserirsi nel mondo del lavoro; una situazione che non è senza conseguenze sulla più elevata percentuale di NEET (giovani che non studiano e non lavorano), fenomeno che – oltre ad implicare costi personali elevati per quanti lo vivono – lascia inutilizzata una parte del capitale umano giovanile, potenzialmente la più dinamica per il Sud, deprimendo il tasso di sviluppo dell’intero Paese. Lo vediamo nella limitata presenza al Sud degli Istituti Tecnologici Superiori: gli ITS offrono una formazione terziaria professionalizzante in linea con le qualifiche medio-superiori richieste dall’evoluzione in atto nei processi produttivi, così da far registrare tassi di occupazione post-diploma molto elevati. E lo vediamo nella migrazione studentesca verso le università del Centro-Nord – un fenomeno di rilievo non solo quantitativo ma anche qualitativo – a fronte di una presenza pur importante e qualificata, ma quantitativamente insufficiente, di università meridionali di eccellenza e di forti academy ad esse collegate.
Sono i temi al centro delle sessioni in cui il Convegno di Merita è organizzato: ad esse rinviamo per una analisi più approfondita e per le indicazioni operative. Qui segnaliamo come al potenziamento dell’istruzione e della formazione nel Mezzogiorno deve corrispondere una politica industriale che stimoli lo sviluppo di attività produttive in grado di offrire uno sbocco lavorativo quantitativamente e qualitativamente adeguato. E’ per questo che alle sessioni più specificamente dedicate a scuola e università abbiamo affiancato una riflessione su alcuni rilevanti tematiche connesse al tessuto produttivo meridionale. Così, analizzeremo i problemi di attivazione di una forte formazione professionale all’interno delle aziende e il ruolo delle imprese nell’interazione con i percorsi scolastici, nonché l’attivazione di scuole aziendali di alta formazione. E ragioneremo, sulla base del Rapporto proposto da SRM, sulle caratteristiche delle filiere produttive meridionali, i loro punti di forza e le potenzialità di crescita, gli anelli mancanti o insufficientemente sviluppati. E analizzeremo, sulla base di un Policy Brief di Merita, il ruolo che sta svolgendo la politica di incentivi agli investimenti della ZES unica, evidenziandone alcuni limiti di efficacia e proponendo correttivi che la rendano fino in fondo una leva forte per lo sviluppo del tessuto produttivo meridionale.
Assunzioni di responsabilità
Il permanere e, per certi versi, l’accentuarsi del divario in una materia come istruzione e formazione, così sensibile per la vita dei cittadini e per le prospettive di sviluppo economico e civile, ci interroga sull’adeguatezza delle politiche fin qui attuate e sul corretto rapporto tra poteri di indirizzo dello Stato centrale e ruolo delle Regioni e degli Enti Locali. Rinviando alle sessioni dedicate per una maggiore articolazione delle proposte, qui richiamiamo le linee essenziali di intervento da impostare.
Così, in materia di istruzione primaria e secondaria lo Stato deve tornare a svolgere un ruolo forte di supporto e potenziamento degli istituti scolastici meridionali, e non solo in termini di investimenti nell’edilizia e nelle attrezzature scolastiche ma soprattutto nei processi di formazione dei docenti, di accompagnamento nei loro confronti quando operano nelle situazioni sociali più difficili, di omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale dei criteri di valutazione degli studenti al termine dei diversi cicli e dei loro percorsi di apprendimento.
E anche in materia di formazione professionale, è urgente un intervento mirato – sulla base dell’art. 119 (comma 5) della Costituzione – per attivare corsi di formazione nelle Regioni che ne sono più carenti e nel qualificarli in modo che sappiano attrarre e motivare i ragazzi e le ragazze verso percorsi di studio e lavoro alternativi ai licei. E qui sicuramente anche il mondo delle imprese e le stesse amministrazioni regionali devono assumersi la responsabilità di una interazione forte e fattiva che dia il senso di una svolta nei percorsi professionalizzanti al Sud, con la naturale prosecuzione anche nell’ambito della formazione in azienda.
Per non parlare poi della carenza di Istituti Tecnologici Superiori rispetto alle esigenze delle imprese, un campo nel quale si può far leva sulle esperienze positive che nel Mezzogiorno sono già attive, per sollecitare e sostenere finanziariamente la diffusione del modello: qui si tratta di superare l’attuale frammentazione di competenze tra Stato e Regioni, prevedendo poteri reali di indirizzo e coordinamento in capo allo Stato, da supportare con risorse finanziarie ai sensi anche qui dell’art. 119 (comma 5) della Costituzione.
Infine, in campo universitario è necessario potenziare i criteri perequativi del fondo di finanziamento ordinario e, al tempo stesso, rafforzarne i criteri premiali in funzione degli obiettivi di performance formativa: si tratta di orientare a fini di elevamento della qualità dell’insieme del tessuto universitario meridionale una mole di risorse crescente e non decrescente. Incoraggiando e sostenendo le singole realtà universitarie a portarsi verso livelli qualitativi tali da poter gemmare, come già avvenuto nei casi di maggior prestigio, corsi di dottorato e academy scientifico-tecniche che siano di alto profilo e capaci di attrarre i migliori studenti a livello nazionale (e, perché no,. internazionale).
Quello appena descritto è certamente uno sforzo senza precedenti per le nostre istituzioni scolastiche e universitarie e per lo stesso mondo delle imprese, ma è indispensabile per rispondere ai bisogni delle ragazze e dei ragazzi meridionali e per sbloccare la leva più potente di sviluppo del Sud e del Paese tutto, il “fattore umano”.