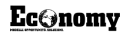Scuola, formazione professionale, ITS
Edizione 2025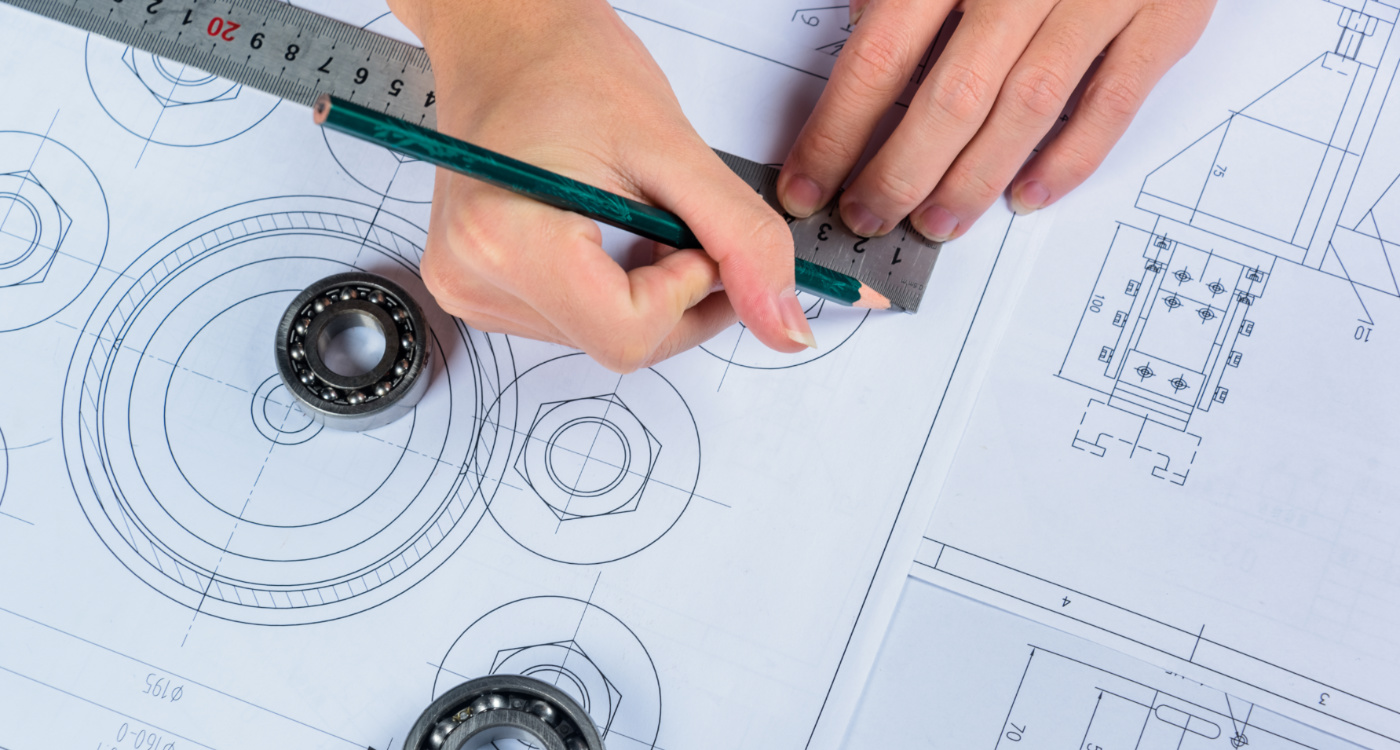
Position paper a cura di Ludovico Albert e Marina Verderajme
Premessa
In Italia, la formazione professionalizzante iniziale è composta dai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), dagli Istituti tecnici e professionali e dagli Istituti Tecnici Superiori, le ITS Academy.
È un sistema caratterizzato da molte eccellenze ma nel suo complesso anche da diversi segnali di affanno. Uno fra gli altri, il mismatch tra offerta e domanda di lavoro che pone alla filiera professionalizzante sia una questione di quantità, troppo pochi i tecnici diplomati, sia un tema di qualità dei profili proposti. Le esperienze formative svolte in alternanza, in modalità duale, in collaborazione con le imprese sono ancora un fatto eccezionale, in generale le imprese denunciano rapporti ancora troppo deboli con le scuole. Una debolezza che peraltro i dati Invalsi evidenziano anche in relazione alle competenze di base degli allievi diplomati e che in molti casi aiutano a infoltire le quote dei giovani NEET. Non a caso il PNRR tra le sue molte condizionalità prevede la riforma della filiera. Il Ministero dell’Istruzione ha avviato una importante sperimentazione, il 4 + 2, affiancata da misure non secondarie di rafforzamento dei Campus, delle relazioni tra i diversi segmenti formativi e il sistema delle imprese. Molta parte del successo di queste iniziative avrà a che fare con la capacità del Ministero di coinvolgere una parte non minoritaria delle scuole e soprattutto con la capacità delle Regioni di programmare e gestire le azioni di supporto e di facilitazione.
La IeFP regionale
Il sistema della IeFP consente percorsi triennali e quadriennali, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali. È un canale di formazione parallelo alla istruzione tecnica e professionale erogata dalle scuole e si svolge presso centri di formazione professionale accreditati. I titoli rilasciati sono: qualifica professionale di Operatore (EQF 3) al termine del 3° anno; diploma professionale di Tecnico (EQF 4) al termine del 4° anno; certificato di specializzazione tecnica superiore (EQF 4/5) dopo un 5° anno opzionale in alcuni percorsi. Dello stesso sistema fanno parte gli IFTS, percorsi post-diploma di durata annuale, che rilasciano il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (EQF 4).
L’ultimo rapporto INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) descrive l’a.f. 2021-2022: gli iscritti al sistema IeFP sono stati 228.572.
Nelle Regioni del Nord la IeFP è oggi un sistema forte, che accoglie e rimotiva una parte consistente dei ragazzi più difficili e a rischio dispersione (la metà degli allievi si iscrive dopo una bocciatura nella scuola) e li porta a conseguire una qualifica o un diploma riconosciuti. I report di Inapp attestano che la maggioranza dei ragazzi si inserisce positivamente nel lavoro, in larga parte coerente con l’indirizzo frequentato, e una quota tutt’altro che residuale di loro si rimotiva e sceglie di riprendere gli studi. Un fatto nuovo, frutto delle scelte del PNRR, è che nel 2023 più di 100mila ragazzi hanno frequentato nella modalità duale, dove le imprese sono a tutti gli effetti soggetti formativi. L’obiettivo del PNRR è di avvicinare la filiera di formazione più legata al lavoro al modello dei paesi di lingua tedesca, anche favorendo la diffusione dei contratti di apprendistato.
Gli studi dell’Inapp sottolineano inoltre che la IeFP contribuisce in modo significativo anche a diminuire il mismatch tra domanda e offerta di lavoro in alcuni settori in cui esso è più acuto: ristorazione, benessere e meccanica.
Il problema è che questo sistema è attivo ed efficiente quasi esclusivamente nelle Regioni del Centro-Nord. Il 62% degli alunni frequentano nelle regioni del Nord. Nelle Regioni meridionali anche i grandi enti, quelli dotati di maggiore vocazione alla presa in carico dei ragazzi più difficili (salesiani, giuseppini del Murialdo etc.), hanno negli anni chiuso le loro sedi impoverendo i territori che oggi, se intendono ripartire, non dispongono più di sedi, laboratori e professionalità dedicate.
Istruzione tecnica e Istruzione professionale
Le caratteristiche del sistema scolastico dell’Istruzione Tecnica e Professionale sono per molti versi specifiche del nostro Paese. Nella maggior parte dei paesi europei la dualità dei percorsi è netta: licei da un lato e filiera professionalizzante dall’altra. Collocare l’Istruzione Tecnica nell’ambito dell’istruzione è stata una scelta che mirava a creare un canale di formazione utile allo sviluppo economico del Paese, meno prestigioso dei Licei, ma comunque partecipe della cultura e dei valori nazionali, nel quale si potesse identificare la classe media. Una scelta molto rilevante per lo sviluppo del paese nel secondo dopoguerra che tuttavia oggi evidenzia segnali di criticità non indifferenti.
Calo degli iscritti
Anche in Italia, nel corso degli ultimi 40 anni, nella scuola superiore si è affermata la “piena scolarità”. Il riparto delle iscrizioni alle superiori si è nel frattempo profondamente modificato:
Iscritti al primo anno di secondaria, percentuali per tipo di scuola
| 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2021 | 2025 | |
| Licei | 34,2 | 35,0 | 37,2 | 40,2 | 52,8 | 55,6 |
| Istituti Tecnici | 41,6 | 42,2 | 37,0 | 32,1 | 32,0 | 31,6 |
| Istituti Professionali | 24,2 | 22,8 | 25,8 | 21,7 | 15,6 | 12,7 |
(Fonte Ministero Istruzione Merito)
Mentre la scuola superiore diventa di massa il costante calo percentuale degli iscritti ai tecnici e ai professionali evidenzia una situazione di crisi piuttosto rilevante.
Si deve peraltro registrare una netta differenza nelle scelte tra Nord e Sud. In Veneto il 39% degli iscritti sceglie un Istituto Tecnico, mentre in Campania la percentuale si ferma al 25% e in Sicilia al 27% (MIM, Febbraio 2025).
Calo dei livelli di apprendimento
Una seconda criticità è la difficoltà dei tecnici e soprattutto dei professionali a garantire livelli di sapere e di competenze accettabili. Più della metà dei diplomati nei tecnici non raggiunge la soglia prevista dalle Indicazioni Nazionali in matematica (e i risultati sono simili nelle altre discipline), ma il dramma è nei professionali dove la quota dei non sufficienti supera l’80%!
Due risposte vere ma parziali al perché del declino dei tecnici e dei professionali nelle scelte dei giovani sono:
- l’orientamento nella scuola media non funziona, persiste una cultura sociale per cui i tecnici e i professionali continuano a essere considerati percorsi di serie B, se non C, consigliati dagli insegnanti a chi è meno bravo, o ai più poveri e agli stranieri,
- la liceizzazione di questi due segmenti. Negli anni hanno perso le discipline tecnico-pratiche e sono, soprattutto nel primo biennio, molto simili ai licei, e allora perché non frequentare direttamente un liceo? Tanto più che molti licei propongono curvature in concorrenza diretta con i tecnici (liceo economico-sociale, liceo scientifico-scienze applicate etc).
Il rapporto con le imprese
Un ulteriore elemento di criticità è la difficoltà dei tecnici e dei professionali a costruire relazioni forti con i sistemi locali delle imprese, a fornire competenze adeguate, sia come quantità, sia dal punto di vista della qualità, utili alle loro scommesse di sviluppo. Fino agli anni 2000 i tecnici e i professionali sono stati ascensori sociali molto efficaci, hanno consentito ai periti, ai geometri e ai ragionieri carriere importanti nelle imprese. Oggi, questa funzione è, almeno in parte, ridimensionata, anche a causa della tendenza generale in tutti i paesi avanzati a spingere verso l’alto i livelli di studio, sia per le caratteristiche dell’offerta di lavoro, sia per la tendenza a investire su carriere di studio più lunghe. Le indagini di Excelsior confermano che la domanda di tecnici rimane inevasa, ma in molti settori le caratteristiche della domanda delle imprese specificano che i tecnici debbono avere un livello di preparazione più alto, universitario, per lo meno di tecnico superiore (ITS) o qualche anno di esperienza.
I risultati di Eduscopio (Fondazione Agnelli) sugli esiti degli istituti tecnici a due anni dal diploma ci dicono che gli occupati (almeno sei mesi nei due anni) sono il 34%, gli universitari (a tempo pieno e lavoratori) il 35%. Se si guarda alla coerenza con la qualifica di chi risulta lavoratore ci si ferma al 35% dei diplomati lavoratori, con peraltro molte differenze tra i diplomati del Nord e del Sud, in Sicilia solo il 21% dei diplomati risulta occupato. Il mismatch tra la domanda delle imprese e i profili professionali in uscita dagli Istituti Tecnici e Professionali contribuisce peraltro anche ad appannare la loro funzione sociale, perché sono meno in grado di presentarsi come via per carriere di lavoro e vita di successo.
Ci sono tecnici e professionali in cui la presenza di dirigenti molto capaci e di un tessuto produttivo attento ha permesso miglioramenti molto rilevanti dell’offerta scolastica. Soprattutto là dove le imprese sono state capaci di porsi oltre che come utilizzatori finali anche come partner per l’elaborazione e la curvatura dei curricula, per la disponibilità ad accogliere gli allievi in stage quando non ad assumerli in apprendistato di primo livello, a orientare e arricchire le dotazioni dei laboratori delle scuole, a permettere di utilizzare i propri macchinari anche ai fini della formazione. Un processo virtuoso realizzatosi in molte realtà, un po’ in tutta Italia, ma in modo tutt’altro che sistemico.
È un percorso che si è consolidato soprattutto là dove esso è stato facilitato e strutturato oltre che dalla robustezza del sistema produttivo anche da Regioni capaci di orientare l’offerta scolastica e formativa, con azioni di sostegno alla costituzione di Academy di filiera composte da scuole, agenzie di formazione, università, ITS e imprese, con la promozione di modalità duali nel percorso di apprendimento (sostegno ai tutor aziendali, contributi per l’accompagnamento di contratti di apprendistato etc.), con azioni di orientamento che seguono l’intero percorso dei giovani, anche nella prima fase dell’inserimento in impresa etc. Un insieme di misure che fanno leva sull’autonomia delle scuole, sulla loro possibilità di articolare un’offerta centrata sulle politiche di sviluppo del territorio, oltre che sulle esigenze di apprendimento degli alunni. Una possibilità consentita a parole dalle norme che prevedono il 20% di flessibilità nel curriculum a partire dal primo biennio, quota che può peraltro crescere negli anni successivi. Un’opportunità rimasta sostanzialmente ignorata nella maggior parte delle situazioni, soprattutto per le rigidità del modo in cui viene assegnato alle scuole l’organico da parte del Ministero dell’Istruzione, il cui mantra, nonostante la legge sull’autonomia scolastica, resta l’uniformità della gestione per garantire la prevedibilità della spesa.
Non è quindi un caso che tra le riforme previste come condizionalità dal PNRR ci sia anche quella dell’istruzione tecnica e professionale: Missione 4 – C1 – Riforma 1.1
Il modello 4+2 …
Per far fronte al mismatch tra domanda e offerta di profili tecnici e professionali di cui il nostro Paese soffre ormai in modo strutturale, nel 2024 il MIM ha istituito il 4+2, una filiera formativa tecnologico-professionale, con l’obiettivo di creare un percorso educativo integrato che colleghi l’istruzione secondaria tecnica e professionale con gli ITS Academy e altri enti formativi. Le Regioni, attraverso specifici accordi, possono aderire a questa filiera, definendo modalità operative e promuovendo la creazione di reti denominate “campus“, eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali. È stata inoltre istituita una struttura tecnica di missione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per promuovere questa filiera e un Comitato di monitoraggio nazionale. Per sostenere l’istituzione dei campus, è stato creato un fondo dedicato con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2024 a cui si sommano 80 M€ del PNRR ed è previsto un nuovo avviso per l’acquisto di attrezzature tecnologiche, un grande investimento del Ministero. Il Campus, la filiera più lunga, aperta alla IeFP e alle imprese raccoglie molto della prospettiva europea per la VET (Vocational Education Training), che evidenzia l’esigenza del superamento di una rigida separazione tra l’istanza più orientata e centrata sui saperi accademici (academic drift) e quella più orientata alla specializzazione (vocational drift), e propone una visione più pluralistica, più integrata e flessibile. Una visione che raccomanda una maggiore integrazione tra le competenze tecniche e le soft skill. Anche per questo il modello dell’alternanza non è considerato alternativo, ma condizione della possibilità di fare acquisire a tutti gli studenti una base più solida di conoscenze.
La legge prevede la possibilità che le scuole adottino il modello 4+2, la cui finalità principale è la predisposizione di una filiera tecnico professionale composta da istituti tecnici e ITS. Si ripropone la strada aperta dal ministro Profumo che permette di conseguire il diploma di maturità in quattro anni. Non si è però percorsa la via di una riforma vera e propria per tutti gli istituti tecnici e professionali, cosicché la riforma interesserà solo le scuole che scelgono di percorrere la via volontaria di una “sperimentazione”, quindi una parte molto limitata dell’istruzione tecnica. Nell’a.s. 2024/25 la sperimentazione ha coinvolto 1650 alunni, per l’a.s. 2025/26 gli iscritti sono 5400. Saranno coinvolti 171 Istituti Tecnici con 193 corsi, le scuole superiori nel 2024/25 sono però 2.583, nonostante gli investimenti massicci le scuole coinvolte restano una minoranza. La resistenza del sistema scolastico, nonostante gli incentivi, resta forte.
… e i Patti educativi 4.0
A gennaio di quest’anno è stato pubblicato il decreto attuativo che introduce importanti novità. Per partecipare alla sperimentazione le scuole si devono costituire in rete con almeno un ITS Academy e un’agenzia di formazione professionale (IeFP) “laddove esistenti”. Una rete a cui possono partecipare anche Università, imprese: si chiameranno “Patti educativi 4.0”. Rafforzare la filiera scolastica è importante ma non è detto sia sufficiente per risolvere le sue criticità strutturali.
Le Regioni avranno un ruolo chiave nell’attuazione poiché a loro spetta la programmazione dell’offerta formativa secondo le possibilità e le scelte dei diversi territori. Una funzione che già oggi in alcune Regioni è esercitata con competenza, ma che in altre si limita ad approvare ogni anno, peraltro su proposta del ministero, il dimensionamento scolastico.
Il modello 4+2 si propone come volano importante anche sul piano culturale: ridare valore alla filiera dell’istruzione tecnica facendo leva sull’Its. La possibilità di acquisire in modo più diretto, nello stesso percorso un titolo terziario fa brillare di nuova luce e rende appetibili anche i percorsi secondari orientati al lavoro. Una scommessa importante ma non scontata se l’approccio del duale tipico dell’ITS dovesse non svilupparsi anche negli istituti tecnici, intercettando e valorizzando vocazioni e talenti, in forme e modalità attrattive anche per gli studenti migliori, e soprattutto se l’azione di programmazione fertilizzante delle Regioni non sarà esercitata in modo omogeneo in ogni area territoriale.
Due questioni aperte:
- gli ITS come collo di bottiglia. Per l’ultimo rapporto Indire relativo al 2022 i diplomati ITS sono stati 7.033, nell’a.s. 2024/25 gli iscritti al quinto anno degli istituti tecnici e professionali sono 231.579, la sproporzione è evidente;
- se il titolo importante diventa quello terziario degli ITS, gli altri istituti tecnici e professionali, la grande maggioranza, diventano a tutti gli effetti di serie B?
Anche tenendo conto di queste criticità le esperienze positive delle Regioni del Nord e della provincia autonoma di Trento diventano condizioni indispensabili per il successo del rilancio della filiera. I campus e di Patti educativi 4.0 vanno resi effettivi. Nelle norme del Ministero dell’Istruzione sono presenti da tempo, dalla riforma Moratti (2003), ma la loro realizzazione è rimasta sulla carta senza il contributo delle Regioni a cui spetta la cura della filiera e la messa in campo di azioni capaci di fare uscire le scuole dalle loro logiche interne, di porle in rete con gli altri soggetti del territorio per diventare parte delle politiche di sviluppo, che peraltro è anche la via maestra per permettere ai loro allievi, spesso difficili, di dotare di senso i loro percorsi di apprendimento.
Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy): sistema o nicchia?
Gli ITS Academy offrono formazione terziaria professionalizzante, alternativa all’università, con percorsi biennali o triennali post-diploma e rilasciano: Diploma di Tecnico Superiore (EQF 5) per i percorsi biennali; Diploma di Tecnico Superiore Avanzato (EQF 6) per i percorsi triennali.
Dopo circa 12 anni di esperienze, la legge n. 99/2022, anch’essa tra l’altro parte integrante delle condizionalità del PNRR (Missione 4 C1_ Riforma 1.2), istituisce il “Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”. Con questa legge gli ITS si collocano formalmente nel canale dell’istruzione terziaria professionalizzante e assumono la denominazione di Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
Il canale formativo è finanziato con risorse nazionali e regionali, nell’ambito più generale della competenza regionale di organizzazione dell’offerta formativa professionalizzante.
Il sistema è in lenta crescita. Oggi le Fondazioni ITS, composte da imprese, Istituti tecnici e/o professionali, agenzie formative regionali e Università, sono 147. Nel 2022 7.033 studenti hanno conseguito il diploma, con un tasso di occupazione dell’87% a un anno dal diploma, e il 93,8% di essi svolge un lavoro coerente con il percorso di studi. Il successo occupazionale e la coerenza dell’occupazione rendono gli ITS un’eccellenza della filiera professionalizzante.
Di seguito i numeri del Report Indire 2024 di monitoraggio (anno di riferimento 2022) che sintetizzano funzionamento e risultati degli ITS.
Punto di forza degli ITS è la dualità: anche le imprese sono soggetto formativo. La diffusione e il peso delle ore svolte dai docenti provenienti dal mondo del lavoro sono ormai consolidate e superano la metà del monte ore. La didattica permette di sperimentare direttamente nell’esperienza quanto appreso, connette gli apprendimenti ai contesti aziendali, anche grazie all’alternanza tra attività in aula, laboratori e stage in azienda, in molti casi gli alunni frequentano come lavoratori già assunti dalle imprese con contratto di apprendistato di terzo livello.
Il PNRR Istruzione (Missione 4-C1 investimento 1.4) assegna alle Fondazioni oggi esistenti 1,5 mld con l’obiettivo di raddoppiare gli iscritti entro il 2025 e di rafforzare le strutture e i laboratori a disposizione.
Una questione di quantità cruciale per le politiche di sviluppo
In seguito alla sperimentazione del 4+2, ma anche in considerazione del fatto che sempre di più gli ITS si vedono impegnati in azioni di reskilling per i lavoratori delle imprese, il sistema degli ITS rischia di rimanere troppo piccolo rispetto al fabbisogno che va espandendosi. Un’offerta di eccellenza su cui la Commissione europea insiste con forza perché è ancora piuttosto lontana nelle quantità da quanto avviene in altri paesi, in Germania e in Svizzera i corsi professionalizzanti riguardano il 40% degli studenti provenienti dalle secondarie, da noi il loro contributo eccede di poco l’1%.
Se non si riesce a sviluppare adeguatamente un filone professionalizzante successivo alla maturità, il rischio è che gli istituti tecnici risultino via via meno capaci di essere appetibili e di attrarre gli studenti più bravi e motivati e rimanga difficile il reperimento di manodopera qualificata dal punto di vista tecnologico, paragonabile a quella tedesca o svizzera, privando le aziende delle competenze indispensabili per compiere un salto dal punto di vista della produttività e dell’innovazione. Una delle ragioni che in buona parte spiega, nel confronto con gli altri paesi europei, il ritardo italiano nell’istruzione terziaria e il divario fra la quota di giovani laureati nei corsi triennali del nostro Paese.
Le ipotesi di sviluppo nel modello della sperimentazione 4+2 del MIM, in assenza di un salto forte anche quantitativo fanno inoltre intravvedere il rischio che gli ITS vengano percepiti come una secondaria di sei anni, anziché come un segmento dell’istruzione terziaria, di ordine superiore.
La competenza regionale per la programmazione dell’offerta di formazione
Nel rapporto Indire i numeri dei percorsi erogati risentono, sia della collocazione in aree in cui è maggiore la domanda e la forza del sistema delle imprese, sia della maggiore capacità di programmazione dell’offerta formativa da parte delle Regioni. La distribuzione degli ITS non è infatti uniforme tra Nord e Sud. Le Regioni settentrionali vantano una presenza più capillare, al contrario, nel Mezzogiorno, la presenza degli ITS è meno diffusa.
Inoltre, mentre il Centro e il Nord nel 2022 vedono attive tutte le Fondazioni, il Sud – a parte la bella e importante performance della Puglia (6 Fondazioni attive su 6, con una media di 5,2 corsi per Fondazione) – vede la Campania con 8 Fondazioni attive su 9, la Sicilia con 6 su 9, la Calabria con 1 su 5 e la Basilicata a 0 su 1. Interessante anche notare, in relazione alla solidità della loro compagine organizzativa, che le Fondazioni del Nord erogano ciascuna una media di 4,4 corsi, mentre quelle del Sud 2,4, salvo anche qui la Puglia.
Anche in questo caso è decisiva la capacità delle Regioni di programmare, di accompagnare, valutare, favorire e premiare le fondazioni più capaci, seguire con azioni di sostegno le fondazioni ritenute indispensabili alle politiche di sviluppo che da sole non riescono a decollare, assicurare stabilità e tempi certi nei finanziamenti, prevedere azioni di sostegno alla dualità, per i contratti di apprendistato, per i tutor e i docenti aziendali, attivare un sistema di orientamento mirato, favorire la nascita di academy di filiera, sostenere ora lo sviluppo e il consolidamento dei Campus e di Patti educativi 4.0 etc.
Un insieme di capacità che nelle Regioni del Centro Nord si è consolidata intorno alla gestione dell’istruzione e della formazione professionale ma che nel Sud richiederebbe monitoraggio e poi sostegno e accompagnamento da parte delle Agenzie ministeriali, Indire per il Ministero dell’Istruzione e Sviluppo Lavoro Italia per il Ministero del Lavoro.
Gli ITS come monadi o parte di sistemi più ampi
Sia Fondazione Agnelli, sia Treellle, mettono in evidenza la dimensione di nicchia che ha fin qui contraddistinto il complesso modello paraistituzionale delle Fondazioni di partecipazione, un unicum in Europa, che fin dalla loro nascita ha caratterizzato e reso difficile lo sviluppo degli ITS. Una dimensione di nicchia che tende a strutturare le Fondazioni come singole monadi: nonostante i proclami relativi alla loro rilevanza strategica, restano poco replicabili, incrementabili e lente nel loro sviluppo sul territorio. Restano scarsi i legami con il sistema di istruzione, il che comporta scarsa conoscenza delle loro possibilità tra gli studenti degli ultimi anni e quindi difficoltà di reperimento di allievi. Altrettanto difficili sono i legami con le università, che pure fanno obbligatoriamente parte delle fondazioni, ma che riconoscono con il contagocce i crediti agli studenti in uscita e creano barriere difficilmente superabili a quanti vorrebbero impegnarsi a conseguire una laurea. Anche i legami con le imprese si sono consolidati, ma probabilmente sarebbe velleitario se pensassimo che debbono rispondere a tutte le loro esigenze, ivi comprese quelle sempre più rilevanti di reskilling dei loro lavoratori.
In Germania, per esempio, ci si sta avvicinando a corsi di formazione a cavallo fra il pubblico e il privato ritagliati sui bisogni della singola azienda o del gruppo di aziende. Anche se questa scelta comporta la difficoltà di definire fin dove si deve spingere l’istruzione pubblica per assecondare le esigenze private, la scelta “monocromatica” fatta dal nostro Paese rappresenta una difficile scommessa. Nel dibattito preparatorio del PNRR si è molto discusso sulle possibilità di attivare scuole aziendali o di filiera, dai trasporti per le Ferrovie, alle costruzioni per i grandi lavori, al digitale per le opere di infrastrutturazione etc. Probabilmente può essere più utile tenere in conto che le esigenze del mercato del lavoro per quanto riguarda le competenze sono molto diversificate, con numerosi livelli di gradazione. Anche qui il tema è la predisposizione di strumenti che aiutino a fare sistema, favorendo nei territori le relazioni tra i diversi attori, dai soggetti della bilateralità, alle molte agenzie che operano sul mercato, alle Fondazioni ITS, ai Servizi per l’impiego, alle scuole, alle università etc.
Migliorare l’offerta di lavoro professionalizzato implica indirizzi nazionali e territoriali per accompagnare la strutturazione del sistema che intervengano sui costi, sulla certezza dei tempi, sulla qualità dell’offerta, sulla certificazione e spendibilità degli esiti. Non è soltanto una questione di risorse. Molte Regioni del Nord nel frattempo hanno attuato, anche con la presenza degli ITS, Academy di filiera, sistemi integrati per la certificazione delle competenze etc. Il programma GOL (PNRR Missione 5 C1, 5,5 mld€), che soprattutto nel Sud fatica ad avere esiti accettabili, ci impone di riflettere sulle capacità di programmazione territoriale dell’offerta.
Competenze, risorse e programmazione
La criticità forse più complessa che, almeno in parte, genera le difficoltà evidenziate finora, riguarda la frammentazione delle competenze: gli istituti tecnici e professionali sono competenza del Ministero dell’Istruzione; la formazione per il lavoro (politiche attive del lavoro) del Ministero del Lavoro; l’orientamento e la formazione professionale (IeFP, ITS) delle Regioni, così come delle Regioni è la competenza della programmazione dell’insieme dell’offerta di formazione professionalizzante, iniziale e continua, a livello territoriale. Anche le risorse in campo hanno a che fare con i bilanci delle tre istituzioni, con il non secondario contributo anche finanziario di un quarto soggetto: la bilateralità. Molte di queste risorse, peraltro, anche se nel nostro paese finanziano attività ordinarie, si pensi alla IeFP e alle politiche attive del lavoro, sono comunitarie, principalmente FSE e oggi PNRR, anch’esse quindi portatrici di target da raggiungere, condizionalità da rispettare, tempistiche e modalità di funzionamento predefinite. La realizzazione delle diverse attività impone infine il riscorso sussidiario a soggetti privati, per lo più non a fini di lucro, dalle agenzie formative, alle Fondazioni ITS, agli enti del Terzo Settore, ma anche alle imprese che naturalmente il fine di lucro ce l’hanno, con il conseguente necessario rispetto di forme di evidenza pubblica per l’erogazione dei contributi e l’individuazione dei beneficiari.
Un intreccio complicato di competenze e di risorse.
La filiera è tuttavia una sola e la sua forza, la sua efficienza ha sicuramente molto a che fare, oltre che con la lungimiranza della committenza del sistema locale delle imprese e delle rappresentanze delle parti sociali, con la capacità delle Regioni di far dialogare le diverse parti, di valorizzare in buone relazioni il valore di ciascuno, di superare l’episodicità, le finalità e le tempistiche disordinate delle diverse fonti di finanziamento, di costruire un sistema capace di contribuire alle politiche di sviluppo locale consolidando visioni, strutture, risorse e competenze.
Ci vuole molta cura affinché le risorse non si disperdano o, come avviene ancora troppo spesso in alcune Regioni, non vengano rimandate al mittente spesso inutilizzate, e soprattutto perché la loro somma possa portare a ciascuno degli attori un valore aggiunto e quindi una moltiplicazione del loro valore.
Alcune Regioni e Province Autonome hanno negli anni fatto molta strada. Il punto di partenza è stata proprio la IeFP, sia per il suo legame in orizzontale con il sistema scolastico, per le attività di orientamento, per la predisposizione di passerelle perché nelle transizioni tra i sistemi si riconoscano gli apprendimenti acquisiti, sia per il suo legame in verticale con i corsi di specializzazione professionale, IFTS e ITS, e poi nella gestione e nella regolamentazione della formazione permanente e continua.
Molte Regioni hanno imparato a parlare di competenze, di loro certificazione, di associazione degli skill più soft a quelli più hard, a finanziare le attività dei diversi soggetti a risultato (numero di studenti diplomati, assunti in azienda, contratti di apprendistato avviati etc.), un modo molto efficace per superare le logiche interne dei diversi sottosistemi, oltre che per rimuovere le aree di inefficienza clientelare che spesso hanno avuto l’onore delle cronache, non soltanto al Sud.
Si sono prese cura del rafforzamento delle agenzie e delle strutture, anche favorendo l’accesso ai fondi FESR per gli investimenti in nuovi spazi e laboratori tecnologici, hanno fatto nascere Academy di filiera con la partecipazione di imprese, scuole, ITS, università, agenzie formative, anche perché hanno compreso che lo sviluppo di un sistema efficiente è indispensabile sia per le politiche di innovazione e sviluppo, sia per i giovani più in difficoltà e che disporre di ambienti di apprendimento avanzati e di forti legami con le imprese è anche il modo più efficace per includere chi è più a rischio di diventare Neet. Non è certo casuale che nelle Regioni del Nord i tassi di dispersione siano migliori della media europea.
Conclusioni
Il rilancio della formazione professionalizzante in Italia, in particolare nel Mezzogiorno, rappresenta una sfida cruciale per garantire ai giovani pari opportunità o per lo meno buone opportunità di inserimento lavorativo e di sviluppo personale nonché, più in generale, per contribuire al rilancio economico e sociale. Nonostante gli sforzi messi in campo negli ultimi anni, il sistema formativo del Sud soffre ancora di debolezze strutturali che ne limitano l’efficacia e la capacità di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.
Prima di tutto per la debolezza quantitativa della filiera, con una IeFP poco presente e un calo più forte degli iscritti agli istituti tecnici e professionali. Una filiera peraltro resa più debole dalla preoccupante diminuzione dei livelli di apprendimento e dalla strutturale mancanza di servizi e supporti di orientamento in tutti i livelli e ordini scolastici, che rischia di compromettere il futuro dei giovani del Sud, allontanandoli sia da percorsi formativi di livello avanzato sia dalle opportunità occupazionali qualificate da parte delle imprese.
Inoltre, proprio il rapporto tra scuole e imprese nel Sud risulta ancora fragile e disomogeneo. Nonostante qualche rara esperienza virtuosa di collaborazione tra istituti tecnici, agenzie formative, imprese e ITS, la costruzione di reti stabili e sinergiche che coinvolgano il mondo del lavoro nella progettazione e realizzazione dei percorsi formativi rimane un obiettivo da perseguire con maggiore determinazione.
Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato, spesso, dalla incapacità delle Regioni del Sud di garantire una programmazione annuale e continuativa dell’offerta formativa professionale che sia parallela ed integrativa rispetto all’offerta ministeriale. Essa favorirebbe quel sistema virtuoso di integrazione che, come accade in varie Regioni del Nord, offre passerelle e flussi più efficaci per garantire la continuità dei percorsi formativi e di fatto aumenta le possibilità occupazionali giovanili.
Nelle Regioni del Nord non si è trattato di un percorso facile, ad esempio ha implicato ristrutturazioni organizzative con l’attribuzione a un unico dipartimento regionale delle funzioni relative a materie diverse: istruzione, formazione professionale, lavoro e politiche sociali, materie che in molti casi fanno capo originariamente ad assessorati diversi.
Nel Sud prevale invece un modello organizzativo disperso fatto di tante direzioni generali che naturalmente faticano a coordinarsi tra di loro. Anche oggi (febbraio 2025), a differenza delle Regioni del Nord, solo poche Regioni meridionali hanno provveduto a regolamentare e sostenere la sperimentazione delle filiere formative tecnologiche professionali del 4+2.
Per l’efficientamento territoriale in questo settore molto spesso la Conferenza Stato Regioni ha scelto un sistema premiale nell’attribuzione delle risorse in relazione ai risultati raggiunti. Si è trattato di una scelta salutare soprattutto nel favorire la concorrenza delle Regioni del Nord, tra di loro, al conseguimento di risultati migliori. Nel tempo tuttavia, salvo parziali e lodevoli eccezioni, non è stato uno strumento efficace per risvegliare la capacità di programmazione e gestione delle Regioni, soprattutto del Sud, che già in partenza erano più distanti. Anzi il divario in termini di competenze degli uffici si è allargato e, nonostante le discriminazioni positive previste dalle risorse comunitarie, nel tempo il divario anche in termini di risorse attribuite in relazione a ciascun servizio è divenuto difficilmente sostenibile, tanto più se alcuni di quei servizi vanno fatti ripartire da zero.
La premialità non ha sortito risultati soddisfacenti, non è stata soprattutto in grado di far compiere a chi era più indietro il salto che gli consentisse di concorrere ad armi pari con chi era partito prima.
Resta d’altra parte difficile pensare alla soluzione estrema del commissariamento da parte del Ministero del Lavoro (IeFP e formazione continua) o da parte del Ministero dell’Istruzione (IeFP, orientamento e programmazione territoriale dell’offerta). Non a caso non è mai seriamente stata presa in considerazione, nonostante i LEP della IeFP abbiano compiuto 20 anni e in alcune Regioni i suoi corsi non siano presenti e quindi restino un diritto non esigibile da parte dei cittadini. Probabilmente varrebbe la pena una messa a punto dei LEP, perché vecchi e molto parziali. Significherebbe tuttavia porre anche la questione della loro sostenibilità economica, oggi difficilmente compatibili con i vincoli della finanza pubblica. I commissariamenti sono difficili perché implicano assunzioni di responsabilità molto problematiche e complesse nelle relazioni tra diverse istituzioni, oltre che perché le articolazioni territoriali dei ministeri non avrebbero probabilmente né le strutture, né le competenze, né le risorse per sostituire le amministrazioni inadempienti.
Più verosimile pensare a un modello misto, di condizionalità, accompagnamento e discriminazione positiva in relazione agli obiettivi che si intendono raggiungere.
In questa prospettiva i Campus e i Patti educativi 4.0 potranno essere un vero e proprio banco di prova, un’opportunità per sperimentare modelli innovativi di formazione professionale, soprattutto se realizzati in modo cooperativo con il Governo centrale e non sostitutivo, al fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) su tutto il territorio nazionale e ridurre le disparità territoriali. Un percorso in cui sarà centrale, per fornire buone opportunità in tutte le Regioni, il ruolo delle agenzie Invalsi e Indire per il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Sviluppo Lavoro Italia per il Ministero del Lavoro.
Per affrontare queste sfide, è necessario un impegno congiunto da parte del Governo, delle Regioni e degli attori del mondo della formazione e del lavoro che metta al centro il rilancio della formazione professionalizzante, i giovani e le loro aspirazioni, con una visione strategica, sinergica tra istituzioni, scuole, imprese e terzo settore per costruire un sistema formativo capace di rispondere alle sfide del mercato del lavoro e di contribuire allo sviluppo economico e sociale del nostro Mezzogiorno.
Il position paper comprensivo di note a pie di pagina è consultabile dal seguente file