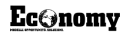Università e Ricerca: Speranze per il Sud
Edizione 2025
A cura di Amedeo Lepore e Mario Rosario Mazzola
Premessa
Il Rapporto sul futuro della competitività europea di Mario Draghi identifica le principali aree di intervento e le direttrici strategiche a esse collegate per rilanciare la presenza dell’Unione su mercati globali, sostenendo, allo stesso tempo, la capacità di coniugare anche in futuro crescita economica e coesione sociale. Si tratta di un obiettivo fondamentale, legato sia all’attitudine di contenere la perdita di posizionamento nei mercati internazionali patita dall’Europa a partire dagli anni Duemila, a fronte dell’affermazione di nuovi concorrenti e potenze economiche, sia alla volontà di garantire per le generazioni future quei livelli di formazione, conoscenza e welfare che hanno contraddistinto il modello socio-economico europeo. Il Rapporto Draghi sottolinea la necessità di affrontare tre grandi cambiamenti strutturali in corso, quali la digitalizzazione, la decarbonizzazione e i cambiamenti geopolitici, individuando nella crescita della produttività e nel superamento del divario dei livelli di innovazione, soprattutto tra Europa e Stati Uniti, una delle chiavi di volta per affermare la crescita futura.
In questa situazione, il Rapporto sottolinea la necessità che l’Unione e i singoli Stati adottino migliori strumenti di analisi e misure per dotare i cittadini di competenze di alta qualità in modo inclusivo. Ciò riguarda molte delle abilità di base, determinanti per la produttività del lavoro, anche al fine di consentire agli individui di partecipare con successo al mercato del lavoro. Obiettivo finale deve essere quello di rafforzare le abilità in cinque ambiti: Digitale, Green, STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), Trasversali, Manageriali.
Queste indicazioni si inseriscono in una serie di analisi e studi che da anni stanno esaminando i mutamenti del mondo del lavoro e dell’impresa. Come sottolineato nel Rapporto 2025 del World Economic Forum (The Future of the Jobs), il 60% dei datori di lavoro intervistati prevede che l’ampliamento dell’accesso digitale trasformerà la loro attività entro il 2030. I progressi tecnologici saranno parte essenziale di questo processo di cambiamento, considerando, in particolare, i loro effetti nei campi dell’intelligenza artificiale e dell’elaborazione delle informazioni (86%), della robotica e dell’automazione (58%), della generazione, dello stoccaggio e della distribuzione di energia (41%). Tali tendenze avranno un effetto divergente sui posti di lavoro, fornendo un chiaro indirizzo, sia per i ruoli in più rapida crescita che per quelli in più rapido declino, e alimentando la domanda di competenze tecnologiche, tra le quali, quelle legate all’intelligenza artificiale e ai big data, alle reti, alla cybersicurezza e all’alfabetizzazione tecnologica, che saranno le prime a svilupparsi largamente. Anche il cambiamento climatico e la transizione verde appaiono come fattori di grande trasformazione nei prossimi cinque anni (rispettivamente per il 47% e il 41% dei datori di lavoro intervistati). Secondo questo rapporto, mediamente i lavoratori possono aspettarsi che il 39% delle loro attuali competenze saranno trasformate o diventeranno obsolete nel periodo 2025-2030.
Venendo al contesto italiano, il Rapporto Excelsior Unioncamere del 2023 – ma aggiornato a luglio 2024 – stima (p. 12) «come somma dell’expansion demand e della replacement demand, un fabbisogno occupazionale complessivo compreso tra 3,4 e 3,9 milioni di unità per il periodo 2024-2028», a seconda che si assuma lo scenario più o meno ottimistico tra quelli previsti per l’andamento del Pil. Ancora (p. 28): «L’analisi delle previsioni dei fabbisogni per il quinquennio 2024-2028 per professione evidenzia che una quota rilevante delle richieste – circa il 39% del totale – riguarderà lavoratori di alto profilo, ossia dirigenti, specialisti e tecnici (tra 1,3 e 1,4 milioni di unità), sia in virtù dell’espansione dell’occupazione sia per la sostituzione di persone in uscita dal mercato del lavoro».
La situazione attuale delle Università italiane
Un utile punto di partenza per esaminare la situazione attuale del modello formativo italiano è rappresentato dai risultati dell’ultimo ranking annuale pubblicato dal Censis nel luglio 2024 (La Classifica Censis delle Università italiane: edizione 2024/2025). Questa articolata analisi del sistema universitario è costruita sulla valutazione degli Atenei (statali e non statali, ripartiti in categorie omogenee per dimensioni) relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità.
In linea generale, le immatricolazioni si sono assestate nell’anno accademico 2023-2024, dopo l’incremento del 3,3% dell’anno accademico precedente. Da notare l’aumento degli iscritti negli Atenei meridionali e delle isole (4,2%) – una novità rispetto alle tendenze di lungo periodo su cui ci soffermeremo più avanti – e del Nord-Est (1,2%), mentre si registra una diminuzione negli Atenei del Centro (-3,6%) e del Nord-Ovest (-2,5%). Va rilevata, poi, una contrazione di studenti, a livello di aree disciplinari, in quelle economica, giuridica e sociale e in quella delle discipline STEM, con una riduzione – in ambedue i casi – del 2,2%. Un altro elemento di valutazione importante è fornito dall’aumento delle donne nelle discipline scientifiche (mediche, farmaceutiche e STEM), mentre le iscrizioni degli uomini sono diminuite dell’1,1% a fronte di un leggero incremento delle donne (0,5%).
Dal punto di vista della valutazione degli Atenei, la performance delle Università del Mezzogiorno è diversificata, con alcuni posizionamenti decisamente positivi. Così, relativamente ai 9 mega Atenei statali (quelli con oltre 40.000 iscritti), troviamo al quarto posto l’Università di Palermo, che guadagna, rispetto all’anno precedente, tre posizioni, mentre più indietro – nona posizione – tra questi che comunque sono tra i migliori atenei italiani, troviamo la Federico II di Napoli. L’Università della Calabria si colloca al vertice della classifica dei 18 grandi Atenei statali (da 20.000 a 40.000 iscritti), l’Università di Cagliari è al quinto posto e in sesta posizione, al pari dell’anno precedente, troviamo l’Università di Salerno. Al dodicesimo posto c’è l’Università di Messina, in crescita di quattro posizioni. Si qualifica come quindicesima l’Università della Campania, seguita dall’Università di Bari, new entry tra i grandi Atenei, perché fino all’anno precedente apparteneva al gruppo dei mega Atenei statali. Chiudono la classifica, in penultima e ultima posizione, l’Università di Chieti e Pescara e l’Università di Catania. Nella classifica dei 16 medi Atenei statali (da 10.000 a 20.000 iscritti), il terzo posto è occupato dall’Università di Sassari, che guadagna una posizione, mentre è decima in graduatoria l’Università del Salento. L’Università di Napoli Parthenope occupa ex aequo la dodicesima posizione, l’Università dell’Aquila si colloca al quattordicesimo posto. Si posizionano, infine, in penultima e ultima posizione della classifica dei medi Atenei statali l’Università di Foggia e l’Università Magna Graecia di Catanzaro. Nella classifica dei 10 piccoli Atenei statali (fino a 10.000 iscritti), l’Università di Cassino si trova in quarta posizione, seguita dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che si classifica quinta, sorpassando l’Università del Sannio, quest’anno in sesta posizione. Al settimo posto si conferma l’Università di Teramo, seguita dall’Università del Molise. La penultima e l’ultima posizione sono, infine, occupate dall’Università della Basilicata e da una new entry, l’Università di Napoli L’Orientale, fino all’anno precedente nel gruppo dei medi Atenei statali. Nella speciale classifica dei 4 Politecnici, il terzo in graduatoria è il Politecnico di Bari. Per quanto riguarda infine la classifica degli Atenei non statali non sono presenti Università del Mezzogiorno fra i 3 grandi Atenei (oltre 10.000 iscritti). Mentre fra i 4 Atenei medi (da 5.000 a 10.000 iscritti), troviamo l’Università Suor Orsola Benincasa al terzo posto.
Nella classifica dell’occupabilità – disponibile solo per gli Atenei statali – in relazione alla percentuale di laureati che a un anno dalla laurea ha trovato occupazione, la posizione delle Università del Mezzogiorno peggiora decisamente. Fra i mega Atenei, la Federico II occupa il penultimo posto e l’Università di Palermo l’ultimo. Fra i grandi Atenei, le Università del Mezzogiorno occupano le ultime 8 posizioni in classifica, mentre fra i medi Atenei quello de L’Aquila si trova al settimo posto e gli altri occupano le ultime 5 posizioni. Fra i piccoli Atenei, quello del Molise occupa il terzo posto, quello della Basilicata il quarto, Cassino il quinto, e gli altri Atenei gli ultimi 4 posti della classifica. Nel caso dei Politecnici quello di Bari occupa invece il primo posto insieme a quello di Milano. L’occupabilità è logicamente legata in modo diretto alla qualità del tessuto economico, produttivo e sociale del territorio in cui ha sede l’Ateneo, perché, insieme al livello della formazione, è questo che garantisce maggiori possibilità di lavoro.
Altre informazioni interessanti derivano dal Rapporto ANVUR del 2023. Tra le novità più rilevanti, vi è la crescita di immatricolazioni delle Università telematiche: nel 2021 vi risultava iscritto l’11,5% del numero totale degli studenti universitari (223.937). Il cambiamento è notevole, se si pensa che un decennio prima solo il 2,5% degli studenti universitari sceglieva i corsi telematici. Nel confronto tra Università pubbliche e private, il numero degli iscritti in quelle pubbliche è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi dieci anni, intorno al 1,6 milioni di studenti, mentre in quelle non statali il numero degli iscritti è aumentato del 21,3%, toccando i 123mila studenti nello stesso arco di tempo.
Nonostante in Italia il numero di laureati resti ancora basso, nel 2020-2021 si contavano 345mila lauree, leggermente in calo rispetto al picco di 372mila dell’anno precedente, ma in crescita del 16% rispetto al 2010-2011. Anche in questo caso, in aumento risultano le Università telematiche, dove nel 2020-2021 è stato ottenuto il 9,9% delle lauree totali (oltre 34mila), in crescita rispetto all’1,7 % di dieci anni prima. I dati dimostrano che, comunque, le caratteristiche degli studenti che frequentano le Università telematiche sono tendenzialmente molto diverse da quelle degli studenti iscritti agli Atenei tradizionali: inseriti nelle fasce medie di età più alte, spesso lavoratori e, nel 50% dei casi, provenienti da un corso tradizionale abbandonato. In altre parole, solo marginalmente le Università telematiche influiscono sulle immatricolazioni degli Atenei in presenza.
Il Rapporto conferma la tendenza degli studenti a spostarsi verso le Università del Centro e, soprattutto, del Nord Italia. Nel 2021-2022, con riferimento alle Università tradizionali (non telematiche), il saldo tra immatricolati e immatricolati residenti è stato positivo negli Atenei del Centro-Nord, attestandosi al 15,1%, a fronte di un saldo negativo del 19,3% per le Università del Mezzogiorno.
Resta poi ancora alto il tasso di abbandono degli studi universitari, che pur riducendosi progressivamente tra il primo e il secondo anno per tutte le lauree (triennali, biennali e a ciclo unico), fino a toccare il minimo nell’anno accademico 2019-2020 (la media di abbandono tra le tre tipologie di lauree era pari al 7,7%), ha fatto registrare un significativo aumento nel 2020-2021, quando la media è salita al 10%. Entro la durata legale del corso, circa uno studente su cinque lascia gli studi universitari e uno studente su quattro rinuncia agli studi dopo sei anni. Secondo il Rapporto (p. 43), sono «dati preoccupanti, che dimostrano come il fenomeno degli abbandoni non sia limitato solo al passaggio tra il primo e il secondo anno e come sia pertanto necessario porre attenzione non solo all’orientamento in ingresso ma anche alle politiche e alle azioni di tutorato nel corso dell’intero ciclo del corso di studi».
Tra gli elementi più significativi vi è proprio la contrazione degli iscritti negli Atenei meridionali: negli ultimi dieci anni, le Università in presenza del Sud hanno perso oltre 100.000 iscritti, rispetto a un aumento di 130.000 studenti al Nord. Questa riduzione è nettamente più elevata di quella che deriva dagli andamenti demografici, in particolare in Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Come è stato rilevato (p. 43): «la fotografia che emerge è quella di un Paese in cui le regioni del Nord-Ovest e del Centro risultano in media più attrattive rispetto a quelle del Mezzogiorno». Inoltre, sono spesso gli studenti più preparati e con maggiori disponibilità economiche a scegliere le Università del Nord. Le cause di questa situazione vanno individuate, innanzitutto, nel momento della scelta universitaria, quando gli studenti preferiscono le aree con maggiori opportunità lavorative. Per di più, l’offerta formativa delle Università del Sud viene spesso percepita come meno attraente e utile di quella delle Università del Nord. Anche se esistono situazioni di eccellenza, gli Atenei meridionali non presentano standards elevati in tutti i campi e le aree disciplinari. Una possibile soluzione sarebbe quella di concentrare le risorse in uno sforzo che possa migliorare il livello dell’offerta formativa delle Università meridionali, spingendo le aree del sapere capaci di conseguire uno standard qualitativo almeno pari a quello degli Atenei del Nord.
Infine, è opportuno riportare anche il dato relativo alla distribuzione delle aree disciplinari nelle Università. Secondo i dati ricavati dall’anagrafe nazionale studenti, questa ripartizione è rimasta sostanzialmente invariata tra l’anno accademico 2011-2012 e quello 2020-2021. Il 35,8% dei diplomi di laurea è stato ottenuto nel campo economico, giuridico e sociale, il 26,6% nell’ambito STEM, il 20,2% in quello artistico, letterario ed educativo, il 17,4% nel settore sanitario e agro-veterinario, in cui si concentra il maggior numero di corsi di studio a programmazione nazionale o locale.
Le dinamiche territoriali
Il Rapporto SVIMEZ 2024 (L’economia e la società del Mezzogiorno. Competitività e coesione: il tempo delle politiche) evidenzia il rischio di una progressiva «desertificazione universitaria» del Sud in virtù di due elementi: sono sempre meno i giovani che decidono di iscriversi all’Università, mentre sempre più spesso i giovani meridionali si laureano altrove. Dopo la pandemia, è ripresa la divergenza tra il Sud (al 55%) e il resto del Paese (al 67%) nell’andamento del passaggio dalla scuola agli studi universitari; laddove, negli ultimi 15 anni, si è notevolmente ridotta la capacità delle Università del Mezzogiorno di immatricolare studenti ivi residenti. Infatti, due giovani del Sud su dieci (20.000 all’anno) si iscrivono a una triennale nel Centro-Nord, circa quattro meridionali su dieci (quasi 18.000 all’anno) a una magistrale nell’altra parte del Paese. L’aumento consistente dei laureati meridionali tra il 2010 e il 2023 (40.000) è in gran parte legato a titoli conseguiti negli Atenei settentrionali, confermando un processo di drenaggio di capitale umano dal Sud. Ai giovani che si spostano dal Sud al Nord per motivi di studio, si devono aggiungere quelli che si muovono per ragioni di lavoro: dal 2002 al 2022, 500.000 laureati circa si sono trasferiti dal Mezzogiorno al Centro-Nord. Negli stessi anni, la quota di emigrati meridionali con elevate competenze (laurea o titolo di studio superiore) si è quasi quadruplicata, passando dal 10% al 35%. Se a questi dati, si sommano quelli relativi al calo demografico, appare chiaro che l’intero sistema della formazione sarà chiamato nei prossimi anni ad affrontare una sfida decisiva, soprattutto nel Mezzogiorno.
Nello studio del 2022 elaborato per Banca d’Italia da Vincenzo Mariani e Roberto Torrini (Il sistema universitario: un confronto tra Centro-Nord e Mezzogiorno), viene evidenziato (p. 5) “il dualismo territoriale tra Nord e Sud del Paese, a cui non si sottrae il sistema universitario. Gli studi e le analisi disponibili mostrano che in media gli atenei meridionali ottengono risultati meno favorevoli nella ricerca; registrano ritardi nella qualità dei servizi e della didattica come percepita dagli studenti; mostrano risultati accademici degli iscritti meno favorevoli e una minore efficienza tecnica complessiva nell’utilizzo delle risorse rispetto agli atenei del Centro Nord”. Al tempo stesso, vengono evidenziati importanti segnali di dinamismo ed esperienze avanzate, dipartimenti di eccellenza e aree disciplinari del tutto innovative. Negli ultimi anni, secondo le indicazioni dei due autori, si è assistito a un progressivo miglioramento dei risultati della didattica, un soddisfacente grado di convergenza degli esiti della ricerca, un consolidamento dell’efficienza degli Atenei del Sud, che hanno portato alla convinzione di un loro possibile rilancio di carattere strutturale.
Analizzando la dinamica delle iscrizioni, i risultati degli studenti e la disponibilità di risorse umane e finanziarie, lo studio Banca d’Italia rileva che: in un decennio le iscrizioni alle Università meridionali degli studenti ivi residenti hanno avuto un trend molto meno favorevole rispetto a quelle del resto dell’Italia; il livello della preparazione secondaria degli studenti del Sud ha rappresentato un elemento di presumibile debolezza per i loro rendimenti universitari; i trasferimenti statali e il numero dei docenti sono pesantemente diminuiti a cominciare dal 2009 in poi.
Il fatto è che il divario di spesa – nel campo dell’istruzione – dell’Italia rispetto alle altre economie avanzate riguarda soprattutto la formazione universitaria. Con riguardo a quest’ultima, secondo i dati Ocse, il problema dell’esiguità dei finanziamenti in Italia è molto serio: all’Università viene destinato solo lo 0,59% del Pil di spesa pubblica, nettamente al di sotto della media europea e dei paesi Ocse (1% circa). La spesa privata, al contrario, è superiore alla media europea (0,45% contro 0,37%). Appare cruciale, quindi, il nodo delle risorse ordinarie destinate all’Università che, in termini reali, sono diminuite dagli inizi degli anni Duemila. Nel 2024, con un taglio del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di circa il 5%, si è interrotta la risalita del finanziamento cominciata nel 2019 e proseguita fino alla fase post-pandemica. Questo tema non è affatto secondario, in quanto il FFO è la parte del bilancio dello Stato destinata a coprire le spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle Università, comprendendo i costi per il personale, le spese per la manutenzione ordinaria e per la ricerca scientifica. Dato che si basa in prevalenza su costo standard per studente, quote premiali e interventi perequativi, è uno strumento di particolare importanza anche dal punto di vista territoriale. Come rileva lo studio Banca d’Italia (p. 7), “gli atenei del Sud e delle Isole scontano un più basso livello di autofinanziamento, dovuto sia alla minore capacità contributiva degli studenti, sia a una minore capacità-possibilità di attingere ad altre fonti, come quelle da privati o provenienti dalla Unione Europea. Fino al 2008, quando risorse, docenti, promozioni crescevano in tutti i territori, le differenze nella capacità contributiva avevano ricevuto ben scarsa attenzione. Essa costituisce invece oggi un fattore di svantaggio per le aree in ritardo che dovrebbe essere tenuto in debito conto, dato che le tasse universitarie determinano insieme ai finanziamenti ministeriali la possibilità di assumere personale”.
Un’inversione di tendenza si è avuta con la dotazione di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che hanno permesso un ampio finanziamento di progetti, ricercatori e dottorati. Tuttavia, a partire dall’anno prossimo, con la scadenza del piano e l’esaurimento dei relativi trasferimenti, la situazione si farà più difficile, soprattutto in relazione alle possibilità di reclutamento e di impiego definitivo, a cominciare dalle figure assunte a tempo determinato nel corso di questi anni. Il PNRR, con la missione 4 ha puntato a sviluppare un’economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza, individuando gli aspetti critici del sistema italiano di istruzione e ricerca, stanziando complessivamente, per tutti i livelli di formazione, 28,29 miliardi di euro (di cui, 17,91 miliardi da sovvenzioni e 10,38 miliardi da prestiti). Tale cifra è stata ripartita in due componenti: il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università (3 miliardi di euro circa sono andati al MUR); il legame tra ricerca e impresa, che si esplica negli investimenti in ricerca e sviluppo destinati a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie e a rafforzare le competenze (8,5 miliardi di euro circa sono stati assegnati al MUR). Gli interventi hanno riguardato, tra l’altro, i centri nazionali di ricerca, gli ecosistemi dell’innovazione, le infrastrutture di ricerca e tecnologiche, i progetti di ricerca, le borse di studio e i dottorati, la mobilità del personale e la figura del ricercatore. Secondo Openpolis, le misure per scuola, Università e ricerca sono state 35 in totale (12 per riforme e 23 per investimenti) e hanno riguardato 59.501 progetti. La percentuale di completamento delle riforme è attualmente del 94% circa, mentre, la spesa effettiva delle risorse del PNRR in questo ampio comparto è solo di poco superiore al 26% (i pagamenti sono al 25%).
Il previsto taglio di parte dei finanziamenti ordinari alle Università e il contesto economico-finanziario di questa fase rischiano però di compromettere a regime gli obiettivi perseguiti con il PNRR.
Oltre i numeri: le strategie di sviluppo
L’Università è chiamata a contribuire fortemente alla crescita della produttività e al superamento del divario dei livelli di innovazione: all’esterno, soprattutto nel rapporto tra Europa e Stati Uniti, e all’interno, nella relazione tra il Sud e il resto dell’Italia e dell’Europa. Da questo punto di vista, occorre una svolta netta per creare una diretta connessione tra l’attività di ricerca, nelle Università e nelle imprese, l’applicazione degli esiti della ricerca nell’innovazione tecnologica e nel trasferimento delle nuove applicazioni all’interno dei processi produttivi nell’industria, nei servizi, nella pubblica amministrazione. Si tratta di una trama complessa, che richiede un ripensamento sia della funzione dell’Università, come luogo di formazione e ricerca non autoreferenziale, ma interdisciplinare e collegato a un contesto in trasformazione, sia del ruolo delle imprese, che vanno chiamate a un più intenso sostegno ai processi di istruzione, formazione e ricerca.
In questa cornice, l’integrazione tra iniziativa pubblica e privata è essenziale, non solo per aumentare la dotazione di risorse da investire nell’Università e nella ricerca, ma anche per fornire un approccio utile alla valorizzazione delle conoscenze (“terza missione”)volto a potenziare un modello di sviluppo avanzato e ad alta produttività. Questi obiettivi richiedono di avvicinare e potenziare sia la ricerca di base che quella applicata, rafforzando il ruolo delle discipline STEM, più portate al dialogo con i fattori reali dell’innovazione, ma anche rivalutando il contributo delle discipline umanistiche e delle scienze sociali, indispensabili alla comprensione del tempo complesso in cui viviamo.
In concreto, questo orientamento può esplicarsi in alcune proposte per il rinnovamento e l’adeguamento dell’Università ai suoi nuovi compiti. Vi sono aspetti positivi che vanno evidenziati e portati a pieno compimento, come l’evoluzione dei metodi di valutazione della qualità della ricerca (che va allargata anche alla valutazione della didattica). In questo ambito – sulla base di un coordinamento da parte dell’ANVUR delle azioni a livello internazionale, seguendo le raccomandazioni della Coalition for Advancing Research Assessment (Coara, <https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/>) – la valutazione è ora principalmente basata su aspetti qualitativi, con un ruolo centrale della revisione tra pari, supportata da un uso responsabile di indicatori quantitativi, evitando una valutazione automatica dei prodotti. In questo modo, si è avviato il superamento di un modello obsoleto, che rinchiudeva il sistema in una gabbia di regole astratte, allontanandolo dalle strade intraprese nei Paesi più avanzati e penalizzando una parte consistente delle discipline scientifiche.
Analoga riflessione è in corso per la riforma dell’abilitazione scientifica nazionale, che potrebbe seguire regole più semplici e dirette, affidando alle procedure di reclutamento la selezione dei meritevoli. In ogni caso, anche in riferimento alle precedenti analisi, la promozione di una nuova leva di studiosi e ricercatori universitari, uscendo da logiche meramente localistiche, appare una necessità ineludibile per potenziare il percorso di rilancio dell’Università.
Un altro elemento di novità è costituito dalla revisione delle classi di laurea ispirata dalla valorizzazione della multidisciplinarità, che può fare da traino a una visione aggiornata dell’Università, più aperta alla dinamica reale dei mutamenti economico-sociali. Questa frontiera innovativa deve diventare sempre più il terreno effettivo di un rapido adeguamento della ricerca, dell’istruzione e della formazione, nel Paese e nel Mezzogiorno, ai processi reali in atto.
Tuttavia, queste finalità hanno bisogno di essere accompagnate da un processo di radicale sburocratizzazione del sistema universitario, che è afflitto oggi più che mai da una cappa di complicazioni amministrative, che impegnano il personale docente oltremodo, distraendolo dai compiti essenziali di didattica e ricerca. Senza un tragitto di ulteriore riforma e semplificazione regolamentare e amministrativa, sarà molto complicato ridare slancio all’Università italiana e, soprattutto, meridionale.
Inoltre, appare irrinunciabile una riflessione sui metodi di insegnamento. La possibilità di cogliere le esigenze di cambiamento del mondo del lavoro e dell’impresa e di rendere la formazione parte di un innalzamento complessivo della competitività del sistema italiano passa anche per un rinnovamento delle metodologie didattiche che, salvaguardando la forza di un modello basato sul confronto partecipativo tra docente e discente, si apra a nuove tecniche legate alle più recenti innovazioni digitali.
Da un altro versante, secondo la già citata ricerca della Banca d’Italia, occorre affrontare le debolezze dell’organizzazione universitaria meridionale che derivano da «fattori di contesto»: la qualità degli studenti in ingresso, lo scarso richiamo del mercato del lavoro e la bassa capacità contributiva delle famiglie meridionali. A questi temi si affiancano le criticità proprie delle Università del Sud, insieme a vaste potenzialità – come i centri di eccellenza e le Academy – da sviluppare in maniera sistemica. In tale direzione, insieme all’indicazione di un incremento significativo delle risorse per le Università a livello nazionale per un riequilibrio con gli altri Paesi avanzati, lo studio Banca d’Italia propone, a favore degli Atenei delle aree in ritardo e afflitte da problemi demografici, (p. 30) l’istituzione di “una riserva di risorse a fini di riequilibrio, […] preferibile alle soluzioni fino ad oggi adottate, che accrescono il costo standard per gli atenei in aree di ritardo o che limitano l’impatto redistributivo dei criteri di finanziamento, diluendone nel tempo gli effetti incentivanti, che andrebbero anzi pienamente valorizzati», mediante premialità per le pratiche più virtuose. Questa misura servirebbe anche a far emergere poli universitari più attrattivi, riportando a livelli fisiologici la mobilità in uscita verso le Università del Centro-Nord.
La prospettiva dell’Università italiana, poi, deve andare oltre l’impulso ricevuto finora (e attuato solo in parte) dal PNRR. Gli obiettivi più recenti sono stati essenzialmente tre: l’accessibilità ai livelli più elevati dell’istruzione, aumentando il numero degli studenti e dei laureati; l’innovazione e la “contaminazione” dei percorsi di studio; l’internazionalizzazione del sistema universitario. Le iniziative del Piano per il conseguimento di questi scopi hanno riguardato, in particolare, l’orientamento su larga scala degli studenti delle scuole superiori per l’iscrizione ai corsi universitari, rafforzando le borse di studio e l’offerta di residenze; i programmi per la connessione tra i saperi scientifici e quelli umanistici, ma anche il sostegno alla formazione tecnica; l’attrazione di ricercatori e studenti dall’estero, la mobilità verso istituzioni internazionali di docenti e studenti italiani, l’incremento delle attività di collaborazione scientifica con l’Europa e i Paesi terzi. Questi percorsi dovrebbero essere ulteriormente potenziati e ampliati. Un’attenzione prioritaria deve essere ancora posta sulla drastica inversione della emorragia di competenze che affligge l’Italia, ma soprattutto le Università meridionali. A questo riguardo, vanno rafforzati i flussi in ingresso di competenze provenienti da altri Paesi europei (e non solo), vanno favorite le uscite per i programmi temporanei di esperienze formative e di ricerca all’estero, vanno consolidati i rientri dei “cervelli” più giovani e preparati. Al tempo stesso, naturalmente, non va trascurata l’esigenza di “trattenere” nei luoghi in cui hanno ricevuto la parte principale dell’opera di istruzione il capitale umano e i talenti dei giovani meridionali, anche aggregando le maggiori capacità formative delle Università del Sud. In questo contesto, una strategia rivolta all’area del Mediterraneo e ai Paesi dell’Africa – anche attraverso la costituzione di apposite Università – potrebbe rappresentare un tassello importante dell’intervento dell’Italia in un territorio cruciale per lo sviluppo economico e per la costruzione dei nuovi assetti geopolitici globali.
Quello descritto è un orizzonte difficile e impegnativo per l’Università italiana ma è oggi più che masi necessario promuovere una simile svolta di fondo se vogliamo riaprire prospettive di crescita culturale e professionale per i giovani del nostro Paese e del Mezzogiorno.